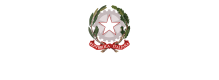Perché le emozioni sono così importanti?
Dall’apprendimento alle relazioni: il ruolo della dimensione affettiva
Le emozioni rappresentano una delle dimensioni più affascinanti e complesse dell’esperienza umana: sofisticati sistemi di elaborazione delle informazioni che orientano i nostri pensieri, guidano le nostre decisioni e plasmano le nostre relazioni sociali. Grazie ai progressi delle neuroscienzeIl cervello umano è una delle strutture più complesse e af... Leggi e della psicologiaLa psicologia è la scienza che esplora la mente, le emozion... Leggi cognitiva, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nella comprensione delle emozioni, scoprendo quanto siano intimamente intrecciate con ogni aspetto della nostra vita, dall’apprendimentoIl termine apprendimento - con i sinonimi imparare, assimila... Leggi alla salute mentaleSecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute m... Leggi, dalle relazioni allo sviluppo dell’identitàIdentità: la trama invisibile che tiene insieme chi siamo L... Leggi.
INDICE
ToggleLa natura delle emozioni
Le emozioni sono definite come stati affettivi complessi, caratterizzati da diverse componenti:
- una soggettiva ed esperienziale (ciò che sentiamo)
- una fisiologica (le modificazioni corporee)
- una espressiva (le manifestazioni visibili)
- una cognitiva (la valutazione della situazione)
- e una motivazionale (la tendenza all’azione).
Paul Ekman, pioniere nello studio delle emozioni, ha identificato sei emozioni primarie o di base, riconoscibili universalmente attraverso le espressioni facciali:
- gioia
- tristezzaLa tristezza è un'emozione fondamentale che rappresenta una... Leggi
- rabbiaLa rabbia rappresenta una delle emozioni primarie più poten... Leggi
- pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi
- disgustoIl disgusto è un'emozione evolutiva di difesa che protegge ... Leggi
- sorpresaLa sorpresa è un’emozione primaria, universale e transito... Leggi.
Queste emozioni hanno radici evolutive profonde e svolgono funzioni adattive fondamentali. La paura, ad esempio, ci prepara a rispondere rapidamente alle minacce, mentre la gioia rafforza i comportamenti che promuovono il benessere e le relazioni sociali.
Accanto alle emozioni primarie, gli psicologi riconoscono l’esistenza di emozioni secondarie o complesse, come la vergognaLa vergogna, un'emozione profondamente radicata nella percez... Leggi, la gelosiaLa gelosia è un fenomeno emotivo, cognitivo e comportamenta... Leggi, l’orgoglioL'orgoglio è un'emozione che svolge un ruolo cruciale nel n... Leggi e la nostalgiaLa nostalgia è un'emozione che coinvolge sia aspetti cognit... Leggi, che emergono dalla combinazione delle emozioni di base con processi cognitivi più elaborati e con l’influenza della cultura e della socializzazione. Queste emozioni richiedono una maggiore maturazione cognitiva e si sviluppano più tardivamente nel corso dello sviluppo infantile.
La teoria dell’appraisal, elaborata da studiosi come Richard Lazarus e Klaus Scherer, sottolinea come le emozioni non siano risposte automatiche agli stimoli esterni, ma dipendano dal modo in cui valutiamo cognitivamente le situazioni. La stessa situazione può generare emozioni diverse a seconda dell’interpretazione che ne diamo: un esame può essere vissuto come una sfida stimolante o come una minaccia paralizzante, a seconda delle nostre valutazioni sulle richieste della situazione e sulle nostre risorse per affrontarla.
Le basi neuroscientifiche delle emozioni
Le neuroscienze affettive hanno rivelato i complessi circuiti cerebrali che sottendono l’esperienza emotiva. Il sistema limbicoIl sistema limbico è una regione chiave del cervello, respo... Leggi, un insieme di strutture situate nella parte più antica del cervello, gioca un ruolo centrale nell’elaborazione emotiva.
L’amigdala
L’amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi, in particolare, funziona come una sorta di centralina per il rilevamento rapido delle minacce e la generazione delle risposte di paura. Studi con tecniche di neuroimagingIl neuroimaging è una disciplina scientifica di grande rile... Leggi hanno dimostrato che l’amigdala si attiva in pochi millisecondi di fronte a stimoli potenzialmente pericolosi, molto prima che possiamo elaborare consciamente l’informazione.
L’ippocampo
L’ippocampoL'ippocampo è una parte del cervello che si trova nella reg... Leggi, strettamente connesso all’amigdala, è fondamentale per contestualizzare le emozioni all’interno delle nostre memorie e esperienze passate. Questa struttura ci permette di ricordare non solo gli eventi, ma anche le emozioni associate a quegli eventi, creando quella che viene chiamata memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi emotiva. È per questo che un profumo particolare può rievocare istantaneamente ricordi carichi di emozione.
La corteccia prefrontale
La corteccia prefrontaleLa corteccia prefrontale svolge un ruolo fondamentale in num... Leggi, la parte più evoluta del nostro cervello, svolge funzioni di regolazione emotiva. In particolare, la corteccia prefrontale ventromediale è coinvolta nella valutazione del significato emotivo delle situazioni, mentre la corteccia prefrontale dorsolaterale è importante per la regolazione consapevole delle emozioni e il controllo degli impulsi.
Antonio Damasio ha dimostrato attraverso studi su pazienti con lesioni a queste aree che le emozioni sono necessarie per prendere decisioni adeguate. Senza l’apporto emotivo, come nel caso dei suoi pazienti, anche le scelte più semplici diventano problematiche.
Il sistema nervoso autonomo
Il sistema nervoso autonomoIl sistema nervoso autonomo (SNA) costituisce una parte esse... Leggi coordina le risposte fisiologiche associate alle emozioni: l’accelerazione del battito cardiaco, la sudorazione, i cambiamenti nella respirazione. Il ramo simpatico prepara il corpo all’azione (la risposta “attacca o fuggi”), mentre il ramo parasimpatico favorisce il rilassamento e il recupero. Questa orchestrazione neurofisiologica mostra quanto le emozioni siano fenomeni che coinvolgono l’intero organismo, non solo la mente.
I neurotrasmettitori
Recenti ricerche hanno evidenziato anche il ruolo dei neurotrasmettitori nell’esperienza emotiva. La serotoninaLa serotonina, nota anche come 5-idrossitriptamina (5-HT), ... Leggi è associata alla regolazione dell’umore, la dopaminaUn neurotrasmettitore che si trova nel cervello e nel sistem... Leggi al sistema di ricompensaCon sistema di ricompensa, detto anche sistema della gratifi... Leggi e motivazioneLa motivazione: un punto di vista scientifico La motivazione... Leggi, mentre il cortisoloLe ghiandole surrenali, piccole ghiandole piramidali sopra i... Leggi, l’ormone dello stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi, media le risposte a lungo termine alle situazioni emotivamente impegnative. Questa base neurobiologica spiega anche perché alcuni disturbi emotivi possano beneficiare di trattamenti farmacologici che agiscono su questi sistemi.
L’alfabetizzazione emotiva: imparare il linguaggio delle emozioni
L’alfabetizzazione emotiva, o competenza emotiva, si riferisce all’insieme di abilità che ci permettono di riconoscere, comprendere, esprimere e regolare le nostre emozioni e quelle altrui. Daniel Goleman ha reso popolare questo concetto attraverso la nozione di intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi, articolata in cinque componenti principali:
- consapevolezza di sé
- autoregolazione
- motivazione
- empatiaL'empatia è un'abilità fondamentale che ci consente di ent... Leggi
- abilità socialiIl cuore relazionale della competenza emotiva Quando si parl... Leggi.
L’alfabetizzazione emotiva è una competenza essenziale per il benessere psicologico. Numerosi studi hanno dimostrato che una maggiore intelligenza emotiva si correla a livelli più bassi di ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi e depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi, migliori capacità di copingIl coping è la capacità di affrontare e gestire lo stress,... Leggi di fronte allo stress, relazioni interpersonali più soddisfacenti e anche migliori risultati nell’apprendimento. L’alfabetizzazione emotiva può essere insegnata e potenziata a qualsiasi età, attraverso programmi specifici come Prefigurare il Futuro di Fondazione Patrizio Paoletti o pratiche come la mindfulnessLa Mindfulness è una pratica di consapevolezza derivata dal... Leggi, che favoriscono la consapevolezza momento per momento delle proprie esperienze emotive.
La nominalizzazione delle emozioni
La nominalizzazioneLa nominalizzazione indica il processo di trasformazione in ... Leggi, ossia la capacità di riconoscere e nominare le proprie emozioni mentre le sperimentiamo, è la pietra angolare dell’alfabetizzazione emotiva. Spesso abbiamo difficoltà in questo compito apparentemente semplice. Sviluppare un vocabolario emotivo ricco e sfumato ci permette di distinguere tra emozioni simili ma non identiche (per esempio frustrazioneLa frustrazione, dal punto di vista neuroscientifico e psico... Leggi e rabbia, tristezza e malinconiaLa malinconia è un'emozione sfaccettata caratterizzata da u... Leggi, ansia e paura). Nominare correttamente un’emozione è il primo passo per comprenderla e gestirla efficacemente.
Per favorire la nominalizzazione delle emozioni e la conoscenza di tutte le nostre sfumature affettive, Fondazione Patrizio Paoletti ha ideato il Glossario dell’Intelligenza Emotiva, che approfondisce le diverse emozioni, considerandone gli aspetti psicologici, cognitivi, neurobiologici e adattivi.
OGNI FIRMA CONTA, Dona il tuo 5x1000
"*" indica i campi obbligatori
SOPRATTUTTO LA TUA.
a Fondazione Patrizio Paoletti
CODICE FISCALE 94092660540
5x1000 promemoria SMS
La regolazione delle emozioni
La regolazione emotiva riguarda le strategie che utilizziamo per modulare l’intensità, la durata e l’espressione delle nostre emozioni. Non si tratta affatto di sopprimere o negare le emozioni, ma di gestirle in modo flessibile e adattivo. Strategie efficaci includono la ristrutturazione cognitiva (cambiare il modo di pensare a una situazione), la distrazione adattiva, la ricerca di supporto sociale, l’espressione costruttiva. La ricerca mostra che una buona regolazione emotiva è associata a migliore salute mentale, relazioni più soddisfacenti e maggiore successo in vari ambiti di vita.
L’empatia
L’empatia, la capacità di comprendere e condividere gli stati emotivi altrui, rappresenta il ponte tra la competenza emotiva personale e quella sociale. I neuroni specchioI neuroni specchio rappresentano una delle scoperte più imp... Leggi, scoperti negli anni Novanta, forniscono una base neurale per questa capacità: i neuroni specchio si attivano sia quando compiamo un’azione sia quando osserviamo qualcun altro compierla, permettendoci di “risuonare” con le esperienze altrui. L’empatia si sviluppa precocemente ed è fondamentale per la costruzione di relazioni significative, per la cooperazioneLa forza silenziosa che tiene insieme i gruppi umani La coop... Leggi e per il comportamento prosociale.
Le emozioni a scuola: strumento di apprendimento
Le emozioni non sono elementi da lasciare fuori dalla porta delle classi, ma sono protagoniste essenziali del processo di apprendimento. Dal punto di vista neuroscientifico, apprendimento ed emozione condividono circuiti cerebrali comuni. L’amigdala, che elabora le emozioni, modula l’attività dell’ippocampo, cruciale per la memoria. Questo spiega perché ricordiamo con particolare vivezza eventi carichi emotivamente: le emozioni agiscono come un “marcatore”, che segnala al cervello quali informazioni sono importanti e meritano di essere consolidate nella memoria a lungo termine.
Un evento caratterizzato da forte impatto emotivo, addirittura, aiuterebbe a cementare anche piccoli dettagli che lo accompagnano, secondo uno studio della Boston University. La ricerca testimonia come accadimenti e contenuti abbastanza banali possono essere impressi in modo profondo nella memoria, se seguono un’emozione molto intensa, gratificante o sorprendente. Ma persino il ricordo dei dettagli precedenti a un evento molto coinvolgente tenderebbe a rafforzarsi, in presenza magari di piccole connessioni o somiglianze con gli elementi dell’evento che impatta emotivamente.
Da questo deriva che un insegnante che riesce a suscitare emozioni positive associate ai contenuti didattici facilita enormemente l’apprendimento e la ritenzione, anche dei piccoli dettagli. Inoltre, la capacità di regolare le proprie emozioni è strettamente legata alle funzioni esecutiveL'espressione 'funzioni esecutive' si riferisce a un insieme... Leggi, come l’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi, la pianificazione e l’inibizione degli impulsi, fondamentali per un apprendimento efficace. Insegnare agli studenti strategie di regolazione emotiva significa quindi dotarli di strumenti che potenziano direttamente le loro capacità di apprendere.
Le emozioni positive e negative a scuola
CuriositàLa curiosità è un'emozione fondamentale che si manifesta c... Leggi, interesse e gioia sono emozioni positive che ampliano i processi cognitivi e favoriscono il pensiero creativo e la risoluzione dei problemi. Le emozioni negative, invece, restringono il repertorio di pensieri e azioni che abbiamo a disposizione, portandoci a focalizzare su risposte immediate. In un contesto di apprendimento, questo significa che studenti che vivono emozioni positive sono più aperti a nuove informazioni, più creativi nell’affrontare i problemi e resilienti di fronte alle difficoltà.
Al contrario, emozioni negative intense come l’ansia, la paura del fallimento o la vergogna possono compromettere gravemente l’apprendimento. L’ansia da prestazione, ad esempio, interferisce con la memoria di lavoroLa memoria di lavoro rappresenta un sistema cognitivo fondam... Leggi, rendendo difficile recuperare informazioni durante un esame, anche se ben apprese. Uno studente costantemente ansioso o stressato ha il sistema nervoso in uno stato di allerta che sottrae risorse cognitive all’apprendimento. Per questo è fondamentale che gli ambienti scolastici siano emotivamente sicuri, dove l’errore è visto come parte del processo di apprendimento e non come motivo di vergogna.
La relazione educante
La relazione insegnante-studente ha una potente valenza emotiva. Gli insegnanti che mostrano calore, supporto ed entusiasmo creano un clima emotivo positivo che facilita l’apprendimento. La teoria dell’attaccamentoAttaccamento: il filo invisibile che connette le relazioni u... Leggi applicata al contesto scolastico suggerisce che l’insegnante può funzionare come una “base sicura” da cui lo studente può esplorare nuove conoscenze. Quando uno studente si sente compreso e sostenuto emotivamente, è più propenso a prendere rischi cognitivi, anche ad ammettere di non aver capito qualcosa e a impegnarsi profondamente nell’apprendimento. Risulta quindi fondamentale formare insegnanti che non siano solo trasmettitori di contenuti, ma anche facilitatori di esperienze emotive positive e modelli di regolazione emotiva.
Emozioni: il tessuto connettivo della socialità
Le emozioni rappresentano il linguaggio fondamentale delle relazioni umane, il mezzo attraverso cui costruiamo connessioni significative e autentiche con gli altri. La capacità di riconoscere, esprimere e regolare le proprie emozioni, così come di percepire e rispondere a quelle altrui, è il fondamento di relazioni sociali di qualità. La competenza emotiva tende a essere il predittore più affidabile della stabilità e soddisfazione relazionale, che beneficia di una sana comunicazione delle proprie emozioni, della validazione delle emozioni dell’altra persona e di una gestione costruttiva dei conflitti.
L’empatia emotiva e la regolazione interpersonale delle emozioni creano un ambiente di “co-regolazione”, con la preziosa capacità di poterci influenzare reciprocamente a livello emotivo, come nel caso di un genitore che calmaLa calma è uno stato emotivo di tranquillità e pace. Da un... Leggi un bambino agitato, un amico che ci aiuta a ridimensionare un’ansia eccessiva o un partner che condivide la nostra gioia amplificandola.
Le emozioni fungono anche da segnali relazionali: la gelosia può indicare che ci sentiamo minacciati nella relazione, la gratitudineLa gratitudine, un'emozione positiva legata al riconosciment... Leggi rafforza i legami, la colpa segnala che potremmo aver violato norme relazionali e ci motiva a comportamenti riparativi. Diventare emotivamente competenti significa imparare a leggere questi segnali in noi stessi e negli altri, rispondendovi in modo appropriato e funzionale, creando circoli virtuosi di comprensione e vicinanza.
Anche la vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi emotiva, ossia la capacità di mostrarci autentici con le nostre emozioni, anche quelle che ci fanno sentire esposti o fragili, favorisce connessioni più profonde. Proprio attraverso la condivisione della nostra vulnerabilità infatti possiamo costruire fiduciaLa fiducia, un'emozione cruciale nel tessuto delle relazioni... Leggi reciproca e intimità genuina. Le relazioni in cui ci sentiamo sicuri nell’esprimere l’intera gamma delle emozioni, senza timoreIl timore è un'emozione complessa che coinvolge l'amigdala,... Leggi di giudizio o rifiuto, sono quelle che ci offrono il maggior senso di appartenenza e supporto.
L’alessitimia: quando le emozioni sono un linguaggio sconosciuto
L’alessitimia, termine che deriva dal greco e significa letteralmente “mancanza di parole per le emozioni”, è una condizione caratterizzata da una marcata difficoltà nell’identificare e descrivere i propri sentimenti e nel distinguere le sensazioni corporee dalle emozioni, nonché da una modalità di pensiero orientata all’esterno piuttosto che all’introspezioneL'introspezione è il processo attraverso il quale possiamo ... Leggi.
Le persone che soffrono di alessitimia spesso descrivono sensazioni fisiche quando gli viene chiesto di parlare delle loro emozioni (“sento un peso allo stomaco” invece di “sono ansioso”), hanno un vocabolario emotivo limitato e faticano a comprendere le sfumature delle proprie esperienze affettive. Questo non significa che non provino emozioni, ma che hanno difficoltà a elaborarle consapevolmente e a nominalizzarle ed esprimerle verbalmente. Si stima che circa tra l’8 e il 13% della popolazione generale presenti livelli clinicamente significativi di alessitimia.
Le conseguenze dell’alessitimia sono significative sulla salute globaleNel vasto e sfaccettato panorama della salute globale, la de... Leggi: è associata a maggiori disturbi psicosomatici, difficoltà nelle relazioni interpersonali e maggiore rischio di disturbi psicologici come depressione e ansia. Approcci che lavorano sulla consapevolezza corporea e sull’alfabetizzazione emotiva possono aiutare le persone alessitimiche a sviluppare una maggiore connessioneConnessione: il bisogno umano che precede ogni tecnologia La... Leggi con la propria vita emotiva e interiore.
L’alfabetizzazione emotiva con Fondazione Patrizio Paoletti
Fondazione Patrizio Paoletti investe in programmi per contrastare l’analfabetismo emotivoL'analfabetismo emotivo è un termine usato per descrivere l... Leggi e sviluppare l’intelligenza emotiva, valorizzando le emozioni nella triade di salute globale: intelligenze, emozioni e relazioni.
Nella scuola AIS Assisi International School di Fondazione Patrizio Paoletti l’educazione emotiva è integrata nella sua progettazione didatticaLa progettazione didattica è un processo chiave nell'ambito... Leggi arricchita, che integra Metodo Montessori e Pedagogia per il Terzo MillennioPedagogia per il Terzo Millennio (PTM) è un metodo interdis... Leggi. Ad AIS insegniamo agli studenti a riconoscere e gestire le emozioni, a sviluppare empatia, a stabilire relazioni positive, a prendere decisioni responsabili. Ad AIS e nei programmi psicoeducativi di Fondazione Patrizio Paoletti per le scuole e i territori, come Prefigurare il Futuro e Oltre le Periferie, l’alfabetizzazione emotiva è uno strumento anche per contribuire a contrastare il disagio psicologicoNel corso della vita, ognuno di noi attraversa fasi compless... Leggi, le forme di violenza e bullismoSebbene non esista una definizione di bullismo universalment... Leggi, proteggendo la salute mentale a lungo termine.
Fondazione Patrizio Paoletti mette anche a disposizione la nuova Collana Emozioni, interamente dedicata al mondo affettivo nelle varie fasi della vita: dall’infanzia all’adolescenzaPer adolescenza si intende il periodo di transizione dalla f... Leggi, dall’età adulta all’anzianità. La collana comprende quattro EduKit scaricabili ed altrettante videolezioni, per imparare a riconoscere le emozioni, nominalizzarle, comunicarle e utilizzarle per orientare pensieri e azioni verso i nostri migliori obiettivi di crescita ed evoluzione, permettendoci di vivere in modo più pieno, connesso e ricco di significato.
- Damasio, A. (1994). Descartes’ error: Emotion, rationality and the human brain. New York: Putnam, 352
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child development, 82(1), 405-432.
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & emotion, 6(3-4), 169-200.
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218.
- Goleman, D. (2005). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam.
- Immordino‐Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, brain, and education, 1(1), 3-10.
- Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. Oxford University Press.
- LeDoux, J. E. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster.
- Tyng, C. M., Amin, H. U., Saad, M. N., & Malik, A. S. (2017). The influences of emotion on learning and memory. Frontiers in psychology, 8, 235933.
- https://www.bu.edu/articles/2025/why-do-we-remember-some-moments-but-not-others/
- Foto di freepic-diller su Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotiva: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Parole chiave
- emozioni
- neuroscienze
- psicologia
- apprendimento
- salute mentale
- identità
- tristezza
- rabbia
- paura
- disgusto
- sorpresa
- vergogna
- gelosia
- orgoglio
- nostalgia
- sistema limbico
- amigdala
- neuroimaging
- ippocampo
- memoria
- corteccia prefrontale
- sistema nervoso autonomo
- serotonina
- dopamina
- sistema di ricompensa
- motivazione
- cortisolo
- stress
- intelligenza emotiva
- empatia
- abilità sociali
- ansia
- depressione
- coping
- mindfulness
- nominalizzazione
- frustrazione
- malinconia
- neuroni specchio
- cooperazione
- funzioni esecutive
- attenzione
- Curiosità
- memoria di lavoro
- attaccamento
- calma
- gratitudine
- vulnerabilità
- fiducia
- timore
- introspezione
- salute globale
- connessione
- analfabetismo emotivo
- progettazione didattica
- Pedagogia per il Terzo Millennio
- disagio psicologico
- bullismo
- adolescenza
- felicità
- Pedagogia
- amicizia
- sport