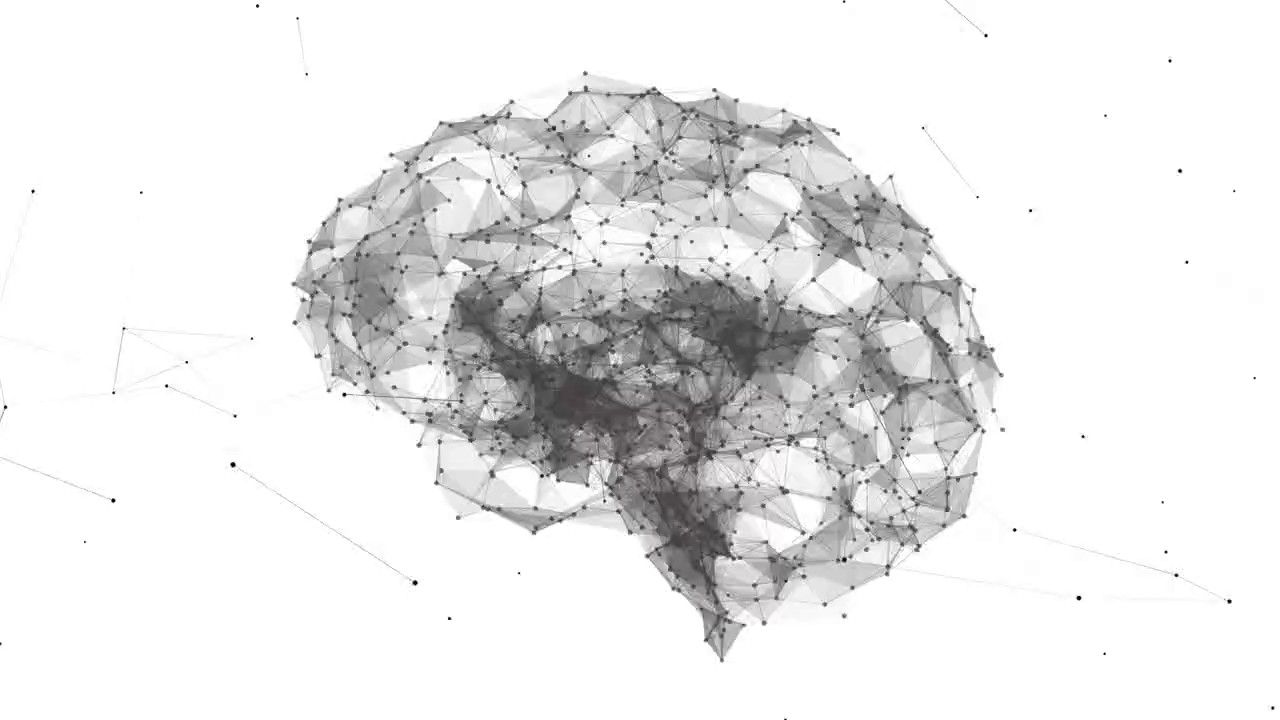
Come reagiamo alle difficoltà?
Il cervello resiliente. Parte II
Segue da “Come reagiamo alle difficoltà? Il cervello “resiliente”. Parte I”
Nella prima parte dell’articolo abbiamo introdotto il concetto di “resilienzaCosa si intende per resilienza? Secondo l'American Psycholog... Leggi” che descrive, in ambito psicologico, un processo dinamico che permette all’essere umano di adattarsi positivamente ad una situazione avversa. Tale adattamento permette a tutti noi di uscire notevolmente rafforzati dalle prove che la vita ci presenta.
In ambito neuroscientifico, come abbiamo già detto, la resilienza è oggetto di forte interesse da parte di numerosi ricercatori. Essi hanno dimostrato, fin ora, che esistono fattori biochimici, genetici e comportamentali che operano insieme per ripristinare il nostro equilibrio emotivo dopo un forte stressCos’è lo stress? Dal punto di vista clinico, lo stress è... Leggi psicologico.
In una situazione di difficoltà, il nostro cervello, ed in particolare l’ipotalamoL'ipotalamo è una struttura vitale e complessa nel cervello... Leggi, che collega il sistema nervoso al sistema endocrino, produce un segnale di stress (ormoni), una “cascata” chimica che ci spinge a difenderci o a fuggire da quella determinata situazione. Il cortisoloLe ghiandole surrenali, piccole ghiandole piramidali sopra i... Leggi, uno di questi “ormoni dello stress”, può danneggiare seriamente le cellule cerebrali dell’ippocampoL'ippocampo è una parte del cervello che si trova nella reg... Leggi e dell’amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi, regioni coinvolte nei processi di memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi e nelle emozioniCosa sono le emozioni e perché non possiamo farne a meno? L... Leggi, al punto da recare gravi conseguenze al nostro equilibrio psico-fisico.
La resilienza va a bloccare questo processo. Aiutati da particolari sostanze biochimiche protettive, infatti, gli ormoni dello stress sembrano disattivarsi più rapidamente nelle persone resilienti.
Gli scienziati hanno individuato alcune di queste sostanze: il DHEA (deidroepiandrosterone), che riduce gli effetti del cortisolo, e il neuro peptide Y, capace di ridurre anche l’ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi. Nel maggio 2010, il prof. Eric Nestler del Mount Sinai Medical Center di New York ha scoperto che una proteina (DeltaFosB) rende i topi più resilienti di fronte allo stress prodotto da solitudineLa solitudine è un'emozione complessa caratterizzata da un ... Leggi o minaccia, inducendolo a ipotizzare che ciò possa essere valido anche per l’uomo.
Al di là di curiose applicazioni futuribili di questi studi (qualcuno ha già immaginato una bevanda a base di DeltaFosB in grado di aumentare la resilienza), è davvero molto importante comprendere che alla base della possibilità di orientare positivamente la nostra vita esiste una predisposizione biologica “positiva”, comune a tutti gli esseri umani.
Tale inclinazione naturale può essere “allenata”, ovvero è possibile educare ed educarsi alla resilienza.
Esattamente come quella della memoria, o dell’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi, la “funzione psichica” della resilienza si modifica nel tempo in rapporto all’ambiente sociale, alle relazioni con gli altri, all’esperienza, ai vissuti e al modificarsi dei meccanismi mentali che la sottendono.
Susanna Kobasa, psicologa presso l’Università di Chicago, ha individuato tre tratti della personalità umana direttamente collegati ad un cervello “più resiliente”: la capacità di impegnarsi per raggiungere uno scopo, l’inclinazione a tenere sotto controllo le azioni e gli eventi in cui si è coinvolti, il gusto per le sfide.
Di queste tre caratteristiche personali possiamo avere consapevolezza, dunque possiamo coltivarle e trasmetterle agli altri.
Non è un caso, ad esempio, che alcune delle più grandi menti del nostro tempo, che hanno offerto il loro contributo alla campagna “Ogni uomo è un educatore” della Fondazione Paoletti (i premi Nobel D. Gross e W. Clark II, il celebre neuroscienziato M. Gazzaniga e altri prestigiosi nomi della scienza, del giornalismo, dell’arte, dello sportLo sport è un'attività fisica che coinvolge abilità fisic... Leggi, ecc.), ci abbiano parlato di impegno, determinazioneLa determinazione è la forza interiore che spinge un indivi... Leggi, capacità di cambiare e raccogliere le sfide, come di imprescindibili chiavi del successo.
Il protocollo di ricerca che la Fondazione Patrizio Paoletti ha attivato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova nel 2010 intende indagare proprio la possibilità di “allenare” la resilienza e aumentare l’autoefficaciaDi fronte alle sfide quotidiane che dobbiamo affrontare, ogn... Leggi nell’individuo, fattori determinanti per il suo successo e la sua realizzazione.
Il consistente corpus di ricerche che ha permesso di ampliare la comprensione dei processi di resilienza e dei sistemi di adattamento umani ha fornito un sostanziale contributo applicativo allo sviluppo di pratiche educative.
Comprendere che tutti siamo programmati per essere resilienti e che tutti possiamo educarci ad esserlo è fondamentale, soprattutto guardando alle future generazioni. Se la resilienza si può apprendere, possiamo anche insegnarla ai nostri bambini.
E proprio grazie alla ricerca scientifica oggi siamo più consapevoli di quali azioni didattiche siano più idonee a sviluppare, specialmente in età evolutiva, quelle capacità che consentono ai bambini di essere resilienti e, di conseguenza, di avere maggiori chance di successo in futuro.
- Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527692.
- Bozkurt, A. (Ed.). (2021). Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy. IGI Global.
- Di Giuseppe, T. et al. (2022). Envisioning the future and the 10 keys for resilience. In RESILIENCE FOR THE FUTURE. An international roundtable to promote resilience in times of the COVID-19 pandemic. https://elearning.fondazionepatriziopaoletti.org/resilience-for-the-future-in-time-of-pandemic-da-covid-19-an-international-round-table
- Gibbs, B., & Papoi, K. (2020). Threading the Needle: On Balancing Trauma and Critical Teaching. Occasional Paper Series, (43). DOI: https://doi.org/10.58295/2375-3668.1350
- Maculan, A., Di Giuseppe, T., Vivaldi, S.; Vianello, F. (2022) Narrazioni e risorse. Gli operatori del sistema penale minorile al tempo del Covid in Autonomie locali e servizi sociali, n2/2022, Edizione Erickson
- Paoletti, P. (2018). OMM The One Minute Meditation. Tenero, CH: Medidea.
- Paoletti, P., Di Giuseppe, T., Lillo, C., Anella, S., & Santinelli, A. (2022). Le Dieci Chiavi della Resilienza. https://fondazionepatriziopaoletti.org/10-chiavi-resilienza/.
- Paoletti, P., Di Giuseppe, T., Lillo, C., Serantoni, G., Perasso, G., Maculan, A., & Vianello, F. (2022). La resilienza nel circuito penale minorile in tempi di pandemia: un’esperienza di studio e formazione basata sul modello sferico della coscienza su un gruppo di educatori. Narrare i gruppi, pagine-01.
- Patrizio Paoletti, Tania Di Giuseppe, Carmela Lillo, Grazia Serantoni, Giulia Perasso, Alessandro Maculan & Francesca Vianello (2023) Training Spherical Resilience in Educators of the Juvenile Justice System during Pandemic, World Futures, DOI: 10.1080/02604027.2023.2169569
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?









