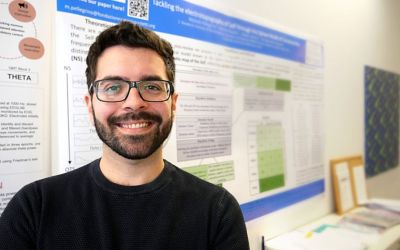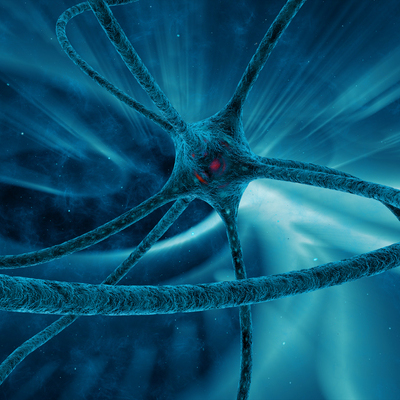La musica nel trattamento delle malattie neurodegenerative
Può la musica aiutare a contrastare la decadenza cerebrale?
La musica rappresenta una componente molto intima della psiche e della forma di vita umana. Essa è, infatti, una caratteristica universalmente presente e culturalmente condivisa da tutta l’umanità. L’attività musicale, che si tratti di ascolto, canto o pratica di uno strumento, viene considerata un fattore importante per la fioritura e il benessere dell’essere umano.
A lungo si è speculato sulla validità della musica in termini del suo contributo al benessere psicofisico dell’individuo e alla salute globaleQual è la definizione di salute proposta dall’OMS nel 194... Leggi. A questo proposito, gli approcci neuroscientifici e molecolari più moderni hanno contribuito a sostanziare l’impatto positivo della pratica musicale sulla psicologia e fisiologia umane. Il grande numero di persone affette in tutto il mondo da demenze e morbo di Alzheimer costituisce una sfida per la scienza e per tutte le discipline che cercano di comprendere queste patologie. La malattia di AlzheimerDefinizione: La Malattia di Alzheimer, anche conosciuta come... Leggi (AD) comporta il blocco delle cellule neuronali da parte di aggregati di proteine abnormi che impediscono ai neurotrasmettitori fisiologici di convogliare messaggi al cervello. Come conseguenza la formazione di nuove memorie e il recupero di quelle acquisite risulta gravemente compromesso. Ciononostante, alcuni tipi di memorie musicali sono preservate nei pazienti AD e questo sorprendente dato apre ad uno dei campi più promettenti della ricerca clinica.
La musica e la neuroplasticità
L’impiego della risonanza magnetica associata al neuroimagingChe cos’è e a cosa serve il neuroimaging? Il neuroimaging... Leggi, da un lato, e di analisi focalizzate sull’espressione dei geni, dall’altro, hanno gettato una luce sui processi neuronali e molecolari attivati dall’esposizione alla musica. Un’ampia letteratura descrive, fin dagli inizi degli anni 2000, le aree del cervello che rispondono agli stimoli musicali. Si parte dalla iniziale percezione nella corteccia auditiva, fino ad arrivare alle zone di elaborazione dello stimolo sonoro nella corteccia prefrontaleLa corteccia prefrontale svolge un ruolo fondamentale in num... Leggi. Il potenziale trasformativo della musica si declina nel sostegno ai processi di neuroplasticità e di rimodellamento dei circuiti neuronali. Come evidenziato da diversi studi, le aree più coinvolte dagli effetti benefici della musica comprendono ampie regioni del cervello legate al processamento sensoriale, alla memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi, alle funzioni cognitive ed emotive.
Effetti benefici della musica nelle neurodegenerazioni
Da qui il passo verso l’utilizzo della musica come attività complementare ai trattamenti farmacologici nelle malattie neurodegenerative è stato breve. Al pari di yoga, meditazioneUna prima definizione per chiarirci le idee Esistono tanti m... Leggi ed altre attività artistiche, la musica ha trovato una consistente applicazione in terapia. Demenze senili, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson sono tra le condizioni neurologiche che meglio risentono dei trattamenti musicoterapici. Miglioramenti nella memoria, nell’orientamento spaziale, così come nei sintomi di depressioneL’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasion... Leggi e ansiaUna definizione neuroscientifica e psicopedagogica L'ansia ... Leggi sono stati riscontrati in molti studi clinici sui malati di AD. In particolare, sintomi particolarmente gravi della malattia, come allucinazioni, deliri, irritabilità e disordini del linguaggio risultano alleviati in pazienti con AD moderato.
LA PLASTICITÀ CEREBRALEIn ambito neuroscientifico, si intende con plasticità cereb... Leggi Una nuova visione del cervello
Compila il form
"*" indica i campi obbligatori
e guarda subito il video
Il ruolo della proteina BDNF
La plasticità neuronale è un processo che può continuare durante tutta la vita adulta, se opportunamente stimolato. Uno dei mediatori più importanti in questo processo è la proteina BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), un fattore coinvolto nella crescita, nelle funzioni e nella sopravvivenza neuronale. BDNF ha, inoltre, un ruolo chiave nella formazione di nuove sinapsiCosa si intende per sinapsi? La sinapsi è un termine utiliz... Leggi, processo basilare nella neuroplasticità. Nelle malattie neurodegenerative questo processo si interrompe. In queste condizioni, i livelli di BDNF diminuiscono drasticamente e prevalgono meccanismi molecolari aberranti che inducono neurodegenerazione. L’esposizione agli stimoli sonori e alla musica si è rivelata importante per la stimolazione della produzione di BDNF. Uno studio del 2007 ha associato per la prima volta l’esposizione alla musica con il miglioramento di funzioni cognitive e l’aumento di BDNF, utilizzando modelli animali. Successivamente, anche nell’uomo è stata determinata l’associazione con l’attivazione di percorsi neuronali alternativi legati a una minore rigidità delle funzioni cognitive.
I “geni” della musica e la “sensogenomica”
Ad un livello più profondo la neuroplasticità è guidata dall’attività di molti geni che regolano la sinaptogenesi e la crescita neuronale. Già nel 2015, utilizzando sofisticate tecniche di analisi dell’attività genica applicate alla malattia di Alzheimer, sono stati messi in luce gruppi di geni influenzati dall’esposizione alla musica. Diversi geni responsabili della neurodegenerazione mostrano livelli di attività inferiori in seguito all’ascolto di musica classica. Al contempo, i trattamenti con la musica sembrano implementare l’attività di geni legati all’apprendimentoCome possiamo definire l'apprendimento? Il termine apprendim... Leggi, alla memoria, alla neurogenesi e alla neuroprotezione. L’impatto degli stimoli musicali sull’espressione di molti geni ha dato la spinta alla nascita di una nuova disciplina chiamata “sensogenomica”. La sensogenomica nasce dalla necessità di una più intensa ricerca in campo genomico, sulla base di evidenze convergenti dell’impatto della musica come stimolo positivo nel trattamento dei pazienti AD.
Esiste, dunque, un link genetico tra la musica e l’Alzheimer, che apre la strada alla progettazione di ulteriori studi interdisciplinari. Integrare approcci molecolari, di risonanza magnetica, comportamentali e psicologici potrebbe essere la chiave per chiarire ulteriormente la natura delle neurodegenerazioni e individuare terapie efficaci. Integrare è alla base della ricerca neuro-psicopedagogica, che permette il dialogo dei saperi e dei professionisti. Con un approccio interdisciplinare, la ricerca scientifica avanza a servizio della salute globale e dell’uomo, anche attraverso la musica.
Sabrina Venditti, ricercatrice presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma.
- Croom, A.M. (2012). Music, neuroscience, and the psychology of well-being: a précis. Frontiers in psychology, 2, Art. 393
- Trainor, L. (2008). Science & music: the neural roots of music. Nature, 453, 598–599.
- Zatorre, R. (2003). Music and the brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 999, 4–14.
- Zaatar et al., (2024). The transformative power of music: Insight into neuroplasticity, health, and disease. Brain, Behavior, and Immunity – Health, 35, Art. 100716.
- Gomez Gallego M. et al. (2017). Music therapy and Alzheimer’s disease: Cognitive, psychological and behavioral effects. Neurología, 32, 300-308.
- Angelucci F. et al. (2007). Investigating the neurobiology of music: Brain-Derived Neurotrophic Factor modulation in the hippocampus of young adult mice. Behavioral Pharmachology, 18, 491-496.
- Minutillo A. et al. (2021). Musical practice and BDNF plasma levels as a potential marker of synaptic plasticity: an instrument of rehabilitative processes. Neurological Sciences, 42, 1861-1867.
- Navarro L. et al. (2023). Sensogenomics of music and Alzheimer’s disease: An interdisciplinary view from neuroscience, transcriptomics, and epigenomics. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, Art. 1063536.
- https://sensogenomics.com
- Foto in evidenza di RDNE Stock project su Pexels.
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità