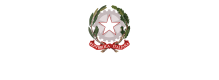Che cos’è l’ortoressia nervosa?
Quando il cibo sano diventa un’ossessione
Viviamo nell’era dell’infodemia, che non risparmia neanche il mondo della salute, dove pillole di benessere, di tutti i colori e forme possibili, sono sempre disponibili su media classici e digitali. Mentre cresce l’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi verso sani stili di vita, la ricerca di una sana alimentazioneLa vita non conosce pause: in ogni essere vivente le funzion... Leggi può, paradossalmente, trasformarsi in un’ossessione. Siamo di fronte alla faccia oscura del salutismo a tavola: l’ortoressia nervosa. Riconoscerla e affrontarla significa comprendere che il vero benessere non è perfezione ma equilibrio. E che anche ciò che consideriamo “buono”, quando è eccessivo, rischia di farci male.
INDICE
ToggleQuali sono le radici dell’ortoressia
Il termine “ortoressia”, coniato nel 1997 dal medico Steven Bratman, deriva dal greco orthos (“giusto, corretto”) e orexis (“appetito”). L’ortoressia rappresenta un’estremizzazione della ricerca di alimenti sani, una strategia disfunzionale di copingIl coping è la capacità di affrontare e gestire lo stress,... Leggi per rispondere alla pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi del “cibo spazzatura” e al bombardamento mediatico dell’importanza di una dieta sana.
Gli scienziati mettono l’ortoressia nervosa in relazione sia ai disturbi del comportamento alimentare, seppure si differenzi da questi per il focus sulla qualità più che sulla quantità, sia al disturbo ossessivo compulsivo. Con quest’ultimo l’ortoressia condividerebbe un’iperattivazione delle aree prefrontali responsabili del controllo inibitorio e una disregolazione del sistema serotoninergico, che influenza sia l’umore che i comportamenti alimentari.
Da un punto di vista psicologico, la ricerca ossessiva per un cibo “puro” nasconderebbe meccanismi di difesa per contenere l’ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi e placare il bisogno di controllo su aspetti della vita percepiti come caotici o minacciosi. Dietro il controllo alimentare, potrebbero celarsi anche sentimenti di inadeguatezza, paura del giudizio sociale o traumi irrisolti.
I fattori di rischio
La ricerca scientifica ha individuato alcuni fattori di rischio che predisporrebbero allo sviluppo di tratti ortoressici, tra cui:
- Il perfezionismo patologico: una tendenza a stabilire standard irrealisticamente o eccessivamente elevati
- Il bisogno di controllo: la necessità di gestire ogni aspetto della propria esistenza
- La rigidità cognitiva: difficoltà nell’adattarsi a cambiamenti o situazioni impreviste
- L’ansia sociale: paura del giudizio altrui che si cerca di compensare attraverso il controllo alimentare
- Le tendenze ossessive: pensieri ricorrenti e comportamenti ripetitivi legati al cibo
Dal punto di vista della prevalenza, l’ortoressia può manifestarsi in diverse fasi della vita. Negli adolescenti, spesso coincide con la ricerca di identità e autonomia, mentre negli adulti può emergere durante periodi di stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi elevato, transizioni di vita significative o in seguito a necessità mediche che richiedano particolari modifiche alimentari.
OGNI FIRMA CONTA, Dona il tuo 5x1000
"*" indica i campi obbligatori
SOPRATTUTTO LA TUA.
a Fondazione Patrizio Paoletti
CODICE FISCALE 94092660540
5x1000 promemoria SMS
L’importanza del contesto sociale
Seppure si tratti di un disturbo che mina la sfera personale, l’ortoressia può essere compresa solo analizzando il contesto socioculturale contemporaneo in cui si manifesta, perché i messaggi mediatici e le pressioni sociali influenzano profondamente i nostri comportamenti, anche alimentari.
Oggi, i social media possono glorificare il clean eating attraverso immagini patinate, storie di successo e testimonianze di influencer che promettono trasformazioni miracolose. Il pericolo maggiore è il diffondersi di una cultura della perfezione, anche a tavola, che può essere particolarmente dannosa per individui vulnerabili, creando aspettative irrealistiche e sensi di colpa quando queste non vengono raggiunte.
Una corretta educazione alimentare dovrebbe invece diffondere l’equilibrio, il bilanciamento, la moderazione, prevenendo lo sviluppo dell’ortoressia grazie al superamento della rigida categorizzazione in “buono” e “cattivo”, che può favorire lo sviluppo di relazioni disfunzionali con l’alimentazione, compresi disturbi alimentari come l’anoressiaL’anoressia nervosa è un disturbo del comportamento alime... Leggi. Addirittura, alcuni studi scientifici propendono per considerare l’ortoressia nervosa una manifestazione “culturale” dell’anoressia.
Prevalenza e rischi dell’ortoressia nervosa
Secondo alcuni studi scientifici, l’ortoressia nervosa colpirebbe il 6,9% della popolazione italiana, ma uno ricerca effettuata su studenti universitari di Pisa ha mostrato una prevalenza addirittura del 35%, con percentuali più elevate tra le donne.
L’ossessione per il cibo sano o “puro” paradossalmente può portare a carenze nutrizionali significative: per esempio deficit di vitamine del gruppo B, ferro, calcio e acidi grassi essenziali, con rischio di compromissione della salute che inizialmente si intendeva proteggere. Naturalmente, alle carenze nutrizionali si associano le emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi negative correlate all’alimentazione, con aumento di ansia, paure e fobieLe fobie sono disturbi d'ansia caratterizzati da una paura i... Leggi.
Come riconoscere l’ortoressia nervosa
Identificare precocemente l’ortoressia nervosa è essenziale per prevenire il deterioramento della qualità della vita. I principali segnali d’allarme includono cambiamenti:
- Comportamentali: per esempio, con un’eliminazione progressiva di alimenti o intere categorie alimentari, rituali rigidi di preparazione dei pasti, rifiuto di mangiare cibi non preparati personalmente, evitamento di situazioni sociali che coinvolgano il cibo.
- Emotivi: ansia intensa quando si devia dalla dieta prescelta, sensi di colpa dopo aver consumato cibi considerati “impuri”, irritabilità quando non è possibile seguire le proprie regole alimentari.
- Sociali: isolamento sociale, perdita di interesse per attività non correlate all’alimentazione, conflitti interpersonali legati alle scelte alimentari.
- Fisici: perdita di peso non intenzionale, affaticamento, problemi digestivi, alterazioni del sonnoCos'è il sonno e perché è importante? Il sonno è uno sta... Leggi e dell’umore.
Prevenzione e approcci terapeutici integrati
Il trattamento dell’ortoressia nervosa richiede un approccio multidisciplinare che integri diverse competenze professionali. La terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata particolarmente efficace nell’aiutare le persone a identificare e modificare i pensieri disfunzionali legati al cibo e sviluppare strategie di coping adattive.
Dal punto di vista nutrizionale, è essenziale il lavoro con un dietista specializzato in disturbi alimentari, per ripristinare gradualmente una relazione equilibrata e positiva con il cibo, introducendo flessibilità e varietà nell’alimentazione, senza compromettere i valori di salute della persona.
La prevenzione dell’ortoressia nervosa richiede anche una riflessione culturale condivisa. È necessario promuovere sempre un’educazione alimentare basata su principi di flessibilità, piacereIl piacere è un'esperienza soggettiva che descrive una sens... Leggi e convivialità, piuttosto che su regole rigide e moralizzazione, anche per riconoscere nel cibo uno strumento di condivisione, gioia e cultura. Anche i professionisti della salute partecipano alla prevenzione, non solo fornendo informazioni nutrizionali equilibrate, ma scegliendo un messaggio moderato, che non alimenti ansie o sensi di colpa. Anche la scuola può contribuire a coltivare una relazione positiva e intuitiva con il cibo.
La salute come equilibrio
L’ortoressia nervosa ci ricorda che anche la ricerca della salute, quando diventa estremizzata e rigida, può trasformarsi nel suo opposto. Il vero benessere non risiede nella perfezione, neanche alimentare, ma in un approccio equilibrato che integri salute fisica, benessere psicologico, soddisfazione sociale e, sì, anche piacere genuino, gioia e rilassamento.
Comprendere l’ortoressia significa riconoscere la complessità dell’essere umano, dove bisogni psicologici, pressioni sociali e vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi si intrecciano in modi spesso imprevedibili. Solo attraverso un approccio consapevole, orientato e scientificamente informato è possibile coltivare una relazione autentica e serena con il cibo, che è specchio dello scambio vitale col mondo e via per un migliore rapporto anche con noi stessi.
- Atzeni, E., Converso, D., & Loera, B. (2020). L’ortoressia nervosa tra attenzione per la qualità dell’alimentazione e disturbi alimentari: Criteri diagnostici e strumenti di valutazione. Rivista di Psichiatria, 55(4), 201-212.
- Bhattacharya, A., Cooper, M., McAdams, C., Peebles, R. e Timko, CA (2022). Cambiamenti culturali nei sintomi dell’anoressia nervosa: il caso dell’ortoressia nervosa. Appetite , 170 , 105869.
- Niedzielski, A., & Kaźmierczak-Wojtaś, N. (2021). Prevalence of orthorexia nervosa and its diagnostic tools—a literature review. International journal of environmental research and public health, 18(10), 5488.
- Foto su Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti