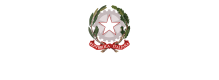Salute mentale
Desolazione
INDICE
ToggleDesolazione in psicologia: quando il vuoto interiore diventa esperienza umana
La desolazione, intesa come stato psicologico, non va confusa con una semplice sensazione di tristezzaLa tristezza è un'emozione fondamentale che rappresenta una... Leggi o con un momento passeggero di malinconiaLa malinconia è un'emozione sfaccettata caratterizzata da u... Leggi. Si tratta di un’esperienza più profonda, complessa e pervasiva, che coinvolge la percezione di sé, il rapporto con gli altri e la capacità di trovare senso e direzione nella propria vita. In termini scientifici, la desolazione è stata studiata in ambito psicologico come una condizione che può emergere in seguito a traumi, perdite, isolamento o esperienze di fallimento.
Dal punto di vista neurobiologico, essa si associa ad alterazioni nei sistemi cerebrali legati all’elaborazione emotiva, in particolare l’iperattivazione dell’amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi e la ridotta funzionalità delle aree prefrontali deputate alla regolazione cognitiva. A livello esistenziale, la desolazione rappresenta un senso di vuoto che va oltre la tristezza clinica e che può sfociare in fenomeni di alienazioneL’alienazione è un concetto centrale in psicologia e psic... Leggi, perdita di motivazioneLa motivazione: un punto di vista scientifico La motivazione... Leggi o disconnessione dagli altri. Per comprenderne la portata, è utile considerare come questo stato influenzi non solo la dimensione individuale ma anche quella sociale, poiché chi sperimenta desolazione tende spesso a ritirarsi, riducendo così la propria partecipazione alla vita collettiva.
Quali sono le caratteristiche psicologiche della desolazione?
La desolazione possiede tratti distintivi che la differenziano da emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi più comuni e transitorie. Essa si manifesta come uno stato che abbraccia l’intero vissuto psichico e che può influenzare sia la dimensione cognitiva che quella affettiva. Tra le principali caratteristiche psicologiche si possono individuare:
- Percezione di vuoto interiore: la persona non avverte solo tristezza, ma un vero e proprio senso di assenza di significato. Non è tanto la mancanza di un oggetto specifico a generare disagio, quanto la sensazione che nulla abbia valore o importanza.
- Ridotta capacità di connessioneConnessione: il bisogno umano che precede ogni tecnologia La... Leggi emotiva: chi vive la desolazione fatica a provare empatiaL'empatia è un'abilità fondamentale che ci consente di ent... Leggi, affettoChe cos'è l'affetto secondo la scienza? L'affetto rappresen... Leggi o vicinanza autentica con gli altri. Questo isolamento interiore può spingere a un progressivo ritiro socialeNegli ultimi decenni, il fenomeno del ritiro sociale ha atti... Leggi.
- Blocco motivazionale: le attività quotidiane, anche quelle che in passato erano fonte di piacereIl piacere è un'esperienza soggettiva che descrive una sens... Leggi o interesse, perdonoIl perdono è un atto complesso, sia emotivo che cognitivo, ... Leggi il loro richiamo. Ne deriva un rallentamento generale delle iniziative, con rischi di stagnazione esistenziale.
- Iper-riflessione negativa: la desolazione è spesso accompagnata da pensieri ricorrenti che insistono sul fallimento, sulla perdita o sull’inutilità della propria esistenza. Questo atteggiamento mentale, simile alla ruminazioneLa ruminazione, definita come una forma di pensiero ripetiti... Leggi depressiva, amplifica la sofferenza.
- Alterazioni fisiologiche correlate: insonniaL'insonnia è un disturbo del sonno che si manifesta con la ... Leggi, mancanza di energia e tensioni somatiche possono rafforzare lo stato psicologico, creando un circolo vizioso difficile da interrompere.
L’insieme di questi elementi rende la desolazione uno stato difficile da superare spontaneamente e, in alcuni casi, preludio a disturbi clinici come la depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi maggiore.
In che cosa la desolazione si distingue dalla depressione?
A prima vista la desolazione può sembrare sovrapponibile alla depressione, ma un’analisi più attenta rivela differenze significative che hanno risvolti importanti anche dal punto di vista clinico e sociale. Questa distinzione non è solo teorica: riconoscere i confini fra depressione e desolazione consente di calibrare meglio strategie terapeutiche e strumenti di supporto. Ecco le principali differenze:
- Temporalità e intensità. La depressione è un disturbo clinico diagnosticabile, con criteri precisi e sintomi che persistono per settimane o mesi. La desolazione, invece, può presentarsi come stato acuto, più fluttuante, ma non per questo meno doloroso.
- Origine esistenziale. Mentre la depressione viene spesso spiegata anche attraverso fattori biologici e genetici, la desolazione è maggiormente legata a esperienze di perdita, isolamento o fallimento sul piano personale e relazionale.
- La depressione tende a intaccare l’autostimaIl termine autostima indica, letteralmente, la valutazione d... Leggi e la fiduciaLa fiducia, un'emozione cruciale nel tessuto delle relazioni... Leggi di base nelle proprie capacità, mentre la desolazione riguarda più il senso complessivo dell’esistenza, con domande profonde sul “perché” e sul “per cosa” vivere.
- Relazione con la realtà esterna. Nella depressione si osserva spesso anedonia, cioè perdita o riduzione della capacità di provare piacere, interesse o soddisfazione in attività che in passato risultavano gratificanti. Nella desolazione, pur essendo presente questa dimensione, essa si accompagna anche a un forte senso di estraneità e disconnessione dal mondo sociale.
- Possibilità di trasformazione. La desolazione, pur essendo fonte di sofferenza, è stata letta da alcuni approcci filosofici e psicologici come occasione di riflessione e riorientamento, un “punto di svolta” esistenziale.
Quali fattori possono generare la desolazione?
Lo stato di desolazione non nasce dal nulla, ma è il risultato di una serie di condizioni psicologiche, sociali ed esistenziali che si intrecciano. Fra i fattori più comuni si possono individuare:
- Eventi traumatici: la perdita di una persona cara, un fallimento lavorativo, una separazione o un evento improvviso che destabilizza la routine possono innescare la sensazione di vuoto.
- Isolamento sociale: la mancanza di relazioni significative è uno dei fattori più potenti. Le neuroscienzeIl cervello umano è una delle strutture più complesse e af... Leggi dimostrano che l’assenza di connessione sociale attiva nel cervello aree legate al doloreIl dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva complessa, ... Leggi fisico.
- Condizioni croniche di stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi: vivere sotto pressione costante, senza risorse di copingIl coping è la capacità di affrontare e gestire lo stress,... Leggi adeguate, può condurre a un logoramento interiore che si manifesta come desolazione.
- CrisiLa parola crisi evoca immagini di instabilità, difficoltà ... Leggi identitarie o di senso: momenti di passaggio esistenziale, come la pensione, il diventare genitori o un cambiamento radicale di vita, possono portare a mettere in discussione l’intero orientamento personale.
- Influenze culturali e storiche: in epoche di incertezzaL'incertezza è uno stato emotivo e cognitivo complesso che ... Leggi collettiva, come guerre, pandemie o crisi economiche, la desolazione diventa un sentimento diffuso che non riguarda solo il singolo, ma intere comunità.
Analizzare questi fattori aiuta a comprendere che la desolazione non è un semplice “problema individuale”, ma un’esperienza intrecciata a dinamiche sociali e culturali.
In che modo la desolazione influisce sulla vita quotidiana?
La desolazione ha conseguenze tangibili che si riflettono sul funzionamento della persona in diversi ambiti della vita quotidiana. Comprendere l’impatto della desolazione permette di riconoscerne i segnali e di intervenire tempestivamente, sia in termini preventivi che di cura. Sul piano personale, può tradursi in una perdita di interesse verso le attività abituali, in difficoltà di concentrazioneChe cos’è davvero la concentrazione e perché oggi è cos... e in una ridotta capacità di prendere decisioni. Nella sfera sociale, essa genera isolamento, diminuzione dei rapporti interpersonali e una percezione di estraneità rispetto al gruppo di appartenenza. Questo distaccoIn psicologia, il distacco indica la capacità — o la tend... Leggi può creare un circolo vizioso: meno relazioni significative si coltivano, più cresce la sensazione di vuoto e abbandonoL’abbandono è una delle esperienze umane più intense e c... Leggi. Anche sul lavoro la desolazione ha effetti misurabili: riduzione della produttività, assenteismo e burnoutIl burnout è uno stato di esaurimento fisico, emotivo e men... Leggi sono spesso collegati a stati emotivi di questo tipo.
Sul piano della salute, la desolazione può avere ricadute fisiologiche. La ricerca scientifica ha evidenziato come la solitudineLa solitudine è un'emozione complessa caratterizzata da un ... Leggi e la mancanza di senso siano associate a un aumento del rischio cardiovascolare, a indebolimento del sistema immunitario e a un maggiore livello di infiammazione cronica. A livello psicologico, essa alimenta pensieri negativi, accentua la percezione di impotenza e può condurre a condotte autolesive. Un esempio pratico è quello delle persone anziane che, vivendo sole e prive di stimoli sociali, sviluppano stati di desolazione che peggiorano progressivamente la loro salute complessiva.
Quali strategie possono aiutare a superare la desolazione?
Affrontare la desolazione richiede interventi mirati, che tengano conto della sua natura complessa. Non esistono soluzioni univoche, ma una combinazione di strategie può offrire un sostegno significativo.
- Supporto psicologico: la psicoterapia, in particolare gli approcci centrati sulla persona e quelli cognitivi, aiuta a riconoscere i pensieri disfunzionali e a ricostruire una narrazione di sé più positiva.
- Rete sociale: coltivare relazioni autentiche rappresenta uno dei rimedi più efficaci. Anche piccoli gesti quotidiani di connessione (una telefonata, un incontro, un gruppo di interesse) possono ridurre il senso di vuoto.
- Attività significative: dedicarsi a progetti che restituiscono senso e finalità, come il volontariatoIl volontariato è un'attività di aiuto e servizio resa da ... Leggi o la cura di un hobby creativo, contribuisce a ridare forma all’identitàIdentità: la trama invisibile che tiene insieme chi siamo L... Leggi.
- Interventi di mindfulnessLa Mindfulness è una pratica di consapevolezza derivata dal... Leggi e meditazioneEsistono tanti modi per definire la meditazione, ma forse il... Leggi: queste pratiche allenano la capacità di stare nel presente e riducono l’iper-ruminazione che alimenta la desolazione.
- Cura del corpo: alimentazioneLa vita non conosce pause: in ogni essere vivente le funzion... Leggi equilibrata, sonnoCos'è il sonno e perché è importante? Il sonno è uno sta... Leggi regolare ed esercizio fisico sono fondamentali. Studi neuroscientifici dimostrano che l’attività fisica stimola neurotrasmettitori legati al benessere, come la serotoninaLa serotonina, nota anche come 5-idrossitriptamina (5-HT), ... Leggi.
È importante sottolineare che in alcuni casi la desolazione può richiedere anche un intervento medico, soprattutto se associata a sintomi depressivi o ansiosi rilevanti. La chiave è non affrontarla in solitudine, ma costruire un percorso di accompagnamento che tenga insieme dimensioni psicologiche, sociali e biologiche.
Guarda il video e scopri 3 pratiche per allenare la tua mente
"*" indica i campi obbligatori

MEDITAZIONI GUIDATE
- Boreham, I. D., & Schutte, N. S. (2023). The relationship between purpose in life and depression and anxiety: A meta‐analysis. Journal of clinical psychology, 79(12), 2736-2767.
- Erwin, E. (2019). The concept of meaninglessness. JHU Press.
- Frankl, V. E. (1972). The feeling of meaninglessness: A challenge to psychotherapy. American Journal of Psychoanalysis, 32(1), 85.
- Heidari, M., Borujeni, M. G., & Rafiei, H. (2019). The assessment effect of spiritual care on hopelessness and depression in suicide attempts. Journal of religion and health, 58(4), 1453-1461.
- Israeli, N. (2020). Meaning and meaninglessness of the self. In Re-Visioning Existential Therapy (pp. 227-236). Routledge.
- Kovalenko, O. H., & Spivak, L. M. (2018). Psychological well-being of elderly people: The social factors. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 8(1), 163-176.
- Safeekh, A. T. (2017). Understanding depression: An overview. Archives of Medicine and Health Sciences, 5(1), 107-111.
- Timothy, T. F., & Wong, P. T. (2024). Existential wellbeing may be of utmost importance to many people. Academia Mental Health and Well-Being, 1(3).
- Vanhooren, S. (2019). Struggling with meaninglessness: a case study from an experiential–existential perspective. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 18(1), 1-21.
- https://psicoadvisor.com/come-combattere-il-senso-di-vuoto-che-ci-portiamo-dentro-39144.html Consultato a settembre 2025
- https://www.unobravo.com/post/senso-di-vuoto-interiore Consultato a settembre 2025
- https://www.theway.org.uk/back/433corella.pdf?utm_source=chatgpt.com Consultato a settembre 2025
- Foto di Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria
Parole chiave
- tristezza
- malinconia
- amigdala
- alienazione
- motivazione
- emozioni
- connessione
- empatia
- affetto
- ritiro sociale
- piacere
- perdono
- ruminazione
- insonnia
- depressione
- autostima
- fiducia
- neuroscienze
- dolore
- stress
- coping
- Crisi
- incertezza
- concentrazione
- distacco
- abbandono
- burnout
- solitudine
- volontariato
- identità
- mindfulness
- meditazione
- alimentazione
- sonno
- serotonina
- salute mentale
- intelligenza emotiva