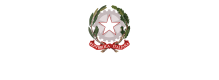Salute mentale
Emarginazione
INDICE
ToggleEmarginazione: quando la società costruisce i suoi confini invisibili
L’emarginazione è un fenomeno trasversale che attraversa le società di ogni epoca, assumendo forme diverse ma mantenendo una costante: la creazione di confini invisibili tra chi è “dentro” e chi è “fuori”. Si manifesta come esclusioneL’“Esclusione” non è soltanto un concetto sociale o p... Leggi, isolamento socialeSocial isolation is a psychological and social phenomenon th... Leggi o perdita di riconoscimento e può riguardare individui, gruppi o intere comunità. Non si tratta solo di povertà o disagio materiale, ma anche di una condizione psicologica e simbolica, in cui la persona viene privata del diritto di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e relazionale.
Dal punto di vista sociologico, l’emarginazione è un processo che nasce dall’interazione tra fattori strutturali (come disuguaglianze economiche o discriminazioni istituzionali) e fattori culturali (pregiudizi, stereotipi, paure collettive). In termini psicologici, comporta un progressivo deterioramento dell’autostimaIl termine autostima indica, letteralmente, la valutazione d... Leggi, della fiduciaLa fiducia, un'emozione cruciale nel tessuto delle relazioni... Leggi negli altri e della percezione di sé come soggetto attivo nella società. La persona emarginata tende a interiorizzare il rifiuto, sviluppando sentimenti di vergognaLa vergogna, un'emozione profondamente radicata nella percez... Leggi, impotenza e alienazioneL’alienazione è un concetto centrale in psicologia e psic... Leggi.
Esempi concreti si trovano in ogni ambito: il senzatetto ignorato nello spazio urbano, il migrante stigmatizzato, l’adolescente escluso dal gruppo dei pari, la persona con disabilità trascurata dalle politiche inclusive. Tutti questi casi condividono un meccanismo di fondo: la riduzione dell’altro a un ruolo marginale, a una figura “invisibile”. Riconoscere l’emarginazione significa, quindi, comprendere come il tessuto sociale si costruisca non solo attraverso le appartenenze, ma anche — a volte, purtroppo, soprattutto — attraverso le esclusioni.
Da dove nasce l’emarginazione?
Le origini dell’emarginazione sono molteplici e intrecciano dimensioni economiche, culturali e psicologiche. Comprendere le cause di questo fenomeno è fondamentale per contrastarlo in modo efficace. Tra i principali fattori che generano emarginazione troviamo:
- Disuguaglianze socio-economiche. La povertà, la precarietà lavorativa e la mancanza di accesso ai servizi essenziali (istruzione, sanità, abitazione) creano fratture sociali che isolano intere fasce della popolazione. Chi vive in condizioni di svantaggio viene spesso percepito come “altro”, meno meritevole o persino colpevole della propria condizione.
- Discriminazioni culturali e identitarie. L’appartenenza etnica, religiosa, di genere o l’orientamento sessuale possono diventare motivo di esclusione. La pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi del diverso, alimentata da stereotipi e da dinamiche di potere, contribuisce a costruire barriere invisibili ma profonde.
- Stigmatizzazione psicologica e sociale. Chi presenta tratti o comportamenti non conformi alle norme condivise (come persone con disturbi mentali, ex detenuti o tossicodipendenti) viene spesso ridotto alla propria “etichetta”, perdendo la possibilità di essere visto nella propria interezza.
- Mancanza di politiche inclusive. Quando le istituzioni non garantiscono strumenti di partecipazione e tutela, il rischio di emarginazione aumenta. L’assenza di reti sociali e di percorsi di reinserimento amplifica il senso di isolamento.
L’emarginazione, dunque, non è mai un destino individuale, ma il prodotto di strutture sociali e culturali che tendono a escludere ciò che non si conforma ai propri standard.
In quali forme si manifesta l’emarginazione oggi?
L’emarginazione assume oggi forme sempre più diversificate, spesso sottili e difficili da riconoscere. Queste forme non sono separate: spesso si intrecciano, generando un effetto cumulativo che amplifica la vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi delle persone coinvolte. Tra le principali possiamo individuare:
- Emarginazione economica: si manifesta nell’impossibilità di accedere a risorse fondamentali come lavoro, reddito, casa o istruzione. Un esempio è la cosiddetta “povertà lavorativa”, in cui si lavora ma non si guadagna abbastanza per vivere dignitosamente.
- Emarginazione digitale: la mancanza di competenze informatiche o di accesso a internet crea nuove disuguaglianze, accentuando l’esclusione di anziani, persone in aree rurali o cittadini con basso reddito. In un mondo sempre più connesso, essere offline significa essere invisibili.
- Emarginazione educativa: riguarda bambini e giovani che, per motivi economici, culturali o familiari, restano ai margini dei processi formativi. La dispersione scolasticaLa dispersione scolastica si riferisce alla situazione in cu... Leggi è una delle sue conseguenze più gravi.
- Emarginazione urbana e territoriale: quartieri periferici, aree degradate o zone interne diventano luoghi di marginalità, dove la mancanza di servizi e opportunità genera un senso di abbandonoL’abbandono è una delle esperienze umane più intense e c... Leggi e sfiducia collettiva.
- Emarginazione relazionale: in una società iperconnessa ma emotivamente fragile, molte persone vivono un isolamento invisibile, fatto di solitudini croniche e mancanza di legami significativi.
Quali sono le conseguenze psicologiche e sociali dell’emarginazione?
L’emarginazione lascia tracce profonde nella mente e nelle relazioni umane. Non si tratta solo di un disagio esterno o materiale, ma di una ferita interiore che altera la percezione di sé e degli altri. Dal punto di vista psicologico, vivere ai margini genera una frattura identitaria: chi è escluso perde progressivamente la sensazione di contare qualcosa per gli altri. Numerosi studi di psicologiaLa psicologia è la scienza che esplora la mente, le emozion... Leggi sociale hanno evidenziato che l’esperienza di esclusione attiva le stesse aree cerebrali coinvolte nel doloreIl dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva complessa, ... Leggi fisico — in particolare la corteccia cingolata anteriore — mostrando come il rifiuto sociale sia vissuto dal cervello come una vera e propria minaccia alla sopravvivenza.
Le conseguenze emotive più comuni includono ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi, depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi, rabbiaLa rabbia rappresenta una delle emozioni primarie più poten... Leggi e vergogna, spesso accompagnate da comportamenti di ritiro o di autodifesa. L’individuo emarginato può interiorizzare il giudizio esterno fino a credere di meritare la propria condizione, cadendo in una spirale di impotenza appresa. Nei casi più gravi, questo senso di annullamento porta a disturbi psicosomatici, dipendenze o comportamenti autolesionistici.
Sul piano sociale, l’emarginazione riduce la coesione collettiva e indebolisce il capitale relazionale delle comunità. Quando gruppi interi vengono esclusi — come migranti, senzatetto o minoranze etniche — si formano barriere invisibili che generano paura reciproca, diffidenza e conflitti latenti. L’esclusione diventa così un contagio silenzioso: chi è respinto tende a isolarsi ancora di più, mentre chi esclude perde la capacità di riconoscere l’umanità nell’altro. In questo modo, l’emarginazione non distrugge solo le vite individuali, ma corrode il tessuto stesso della convivenza sociale.
Come si può contrastare l’emarginazione in modo efficace?
Contrastare l’emarginazione significa agire su più livelli contemporaneamente — individuale, sociale e istituzionale — con strategie coordinate e durature. Solo un approccio sistemico e partecipativo può trasformare l’emarginazione da ferita collettiva in occasione di crescita sociale. Tra le azioni più efficaci troviamo:
- Promuovere l’inclusioneL'inclusione non è solo una parola chiave dei nostri tempi,... Leggi educativa e formativa: garantire a tutti pari opportunità di apprendimento e accesso alla cultura è il primo passo per ridurre la marginalità. Scuole inclusive e programmi di alfabetizzazione digitale sono strumenti chiave.
- Sostenere le reti sociali e comunitarie: creare spazi di incontro, dialogoDialogo: quando le parole diventano relazione Il dialogo è ... Leggi e collaborazione — come centri civici, associazioni o cooperative — aiuta le persone emarginate a recuperare fiducia e appartenenza.
- Attuare politiche pubbliche di welfare attivo: non basta l’assistenza economica; servono percorsi di reinserimento lavorativo, housing sociale (modello abitativo che offre case a canone sostenibile) e sostegno psicologico, in un’ottica di autonomia e rafforzamento delle capacità.
- Contrastare gli stereotipi e la discriminazioneNel tessuto sociale contemporaneo, il tema della discriminaz... Leggi: campagne di sensibilizzazione, formazione interculturale e rappresentazioni mediatiche inclusive contribuiscono a modificare le percezioni collettive.
- Coinvolgere le persone emarginate nei processi decisionali: dare voce a chi è ai margini significa riconoscere la loro competenza esperienziale e restituire dignità e sano protagonismo.
Perché la lotta all’emarginazione è una sfida di civiltà
Contrastare l’emarginazione significa agire sul senso stesso di umanità che tiene insieme le società. Non si tratta solo di un obiettivo politico o assistenziale, ma di un processo culturale e morale che interroga i nostri valori più profondi: chi riconosciamo come “parte di noi” e chi, invece, lasciamo ai margini. L’inclusione, in questo senso, è molto più di una parola chiave nelle politiche sociali: è una forma di intelligenza collettiva, capace di trasformare la diversità in risorsa e di rafforzare la coesione sociale.
Una società che esclude si indebolisce. Le ricerche in sociologia e psicologia di comunità mostrano che i contesti inclusivi favoriscono benessere, fiducia e innovazione, mentre quelli segnati da emarginazione generano paura, sfiducia e stagnazione. L’esclusione alimenta la polarizzazione: più cresce la distanza tra centro e margini, più aumenta il rischio di disgregazione sociale e di derive autoritarie. Per questo, la lotta all’emarginazione non è solo una questione etica, ma anche una condizione per la sopravvivenza democratica.
Il futuro delle società pluraliste dipende dalla capacità di riconoscere il valore di ogni individuo, anche di chi non rientra nei modelli dominanti. Educare all’empatia, promuovere la giustizia sociale e costruire istituzioni accessibili sono azioni che ridefiniscono il concetto stesso di civiltà. L’emarginazione è lo specchio delle nostre paure collettive, ma anche l’occasione per superarle. Combatterla significa restituire spazio alla dignità umana, trasformando la società in un luogo di appartenenza reale, dove nessuno sia invisibile e dove la differenza non rappresenti una minaccia, ma un punto di forza comune.
Il periodico semestrale sugli stili di vita e le risorse interioriCosa sono le risorse interiori e perché sono fondamentali? ... Leggi, le emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi, le relazioni e le intelligenze, per una salute globale
"*" indica i campi obbligatori

LEGGI APPASSIONATAMENTE
- Baah, F. O., Teitelman, A. M., & Riegel, B. (2019). Marginalization: Conceptualizing patient vulnerabilities in the framework of social determinants of health—An integrative review. Nursing inquiry, 26(1), e12268.
- Banks, J. A. (2017). Failed citizenship and transformative civic education. Educational Researcher, 46(7), 366-377.
- Beebeejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life. Journal of Urban Affairs, 39(3), 323-334.
- Fluit, S., Cortés-García, L., & von Soest, T. (2024). Social marginalization: A scoping review of 50 years of research. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-9.
- Gidron, N., & Hall, P. A. (2020). Populism as a problem of social integration. Comparative Political Studies, 53(7), 1027-1059.
- Messiou, K. (2019). Understanding marginalisation through dialogue: A strategy for promoting the inclusion of all students in schools. Educational Review, 71(3), 306-317.
- National Academies of Sciences, Medicine, Division of Behavioral, Social Sciences, Medicine Division, Board on Behavioral, … & Loneliness in Older Adults. (2020). Social isolation and loneliness in older adults: Opportunities for the health care system. National Academies Press.
- Rudert, S. C., Möring, J. N., Kenntemich, C., & Büttner, C. M. (2023). When and why we ostracize others: Motivated social exclusion in group contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 125(4), 803.
- Walsh, K., Scharf, T., & Keating, N. (2017). Social exclusion of older persons: A scoping review and conceptual framework. European Journal of ageing, 14(1), 81-98.
- Wesselmann, E. D., Michels, C., & Slaughter, A. (2019). Understanding common and diverse forms of social exclusion. Current directions in ostracism, social exclusion and rejection research, 1-17.
- https://www.minori.it/it/ricerca-guidata?f%5B0%5D=taxonomy_vocabulary_20%3A749 Consultato a ottobre 2025
- https://www.liberties.eu/it/stories/emarginare/44083 Consultato a ottobre 2025
- https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECECESSTAT20221.pdf Consultato a ottobre 2025
- https://www.liberties.eu/en/stories/social-exclusion/43579 Consultato a ottobre 2025
- Foto di Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria