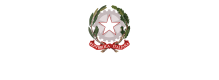Salute mentale
Disturbo dissociativo
INDICE
ToggleDisturbo dissociativo: quando la mente si scollega da sé stessa
La dissociazione è un meccanismo della mente che “scollega” temporaneamente aspetti dell’esperienza che normalmente funzionano insieme: memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi, identitàIdentità: la trama invisibile che tiene insieme chi siamo L... Leggi, percezioni corporee, emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi, senso del tempo. In piccolo, capita a tutti: guidiamo e arriviamo a destinazione senza ricordare i dettagli, assorti nei pensieri. Il disturbo dissociativo, però, è qualcosa di diverso: la disconnessione diventa frequente, intensa, fuori controllo, e produce sofferenza clinicamente significativa. Può coinvolgere vuoti di memoria che non si spiegano con la normale distrazione, la sensazione di osservare sé stessi dall’esterno, la percezione che il mondo sia irreale, fino a una marcata confusioneLa confusione è un'emozione caratterizzata da incertezza, d... Leggi o frammentazione dell’identità. Dal punto di vista scientifico, la dissociazione è intesa come una risposta adattiva a stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi estremi o prolungati, utile nel breve periodo per “spegnere” il doloreIl dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva complessa, ... Leggi psicologico, ma costosa quando si cronicizza perché separa troppo l’esperienza. È un fenomeno più comune di quanto si creda, che può coesistere con ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi, depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi o disturbo post-traumatico. Riconoscerlo è importante: capire che cosa succede al cervello e alla mente permette di ridurre lo stigmaLo stigma verso la salute mentale è definibile come il preg... Leggi e di scegliere percorsi di cura fondati su evidenze.
Quali sono i principali tipi di disturbo dissociativo?
I disturbi dissociativi non si presentano tutti allo stesso modo: la ricerca clinica li ha distinti in diverse forme, ognuna con caratteristiche specifiche che aiutano a comprenderne meglio la natura e a riconoscerli nella vita quotidiana. Ecco i principali:
- AmnesiaL'amnesia è una condizione neurologica che comporta la perd... Leggi dissociativa: si manifestano vuoti di memoria relativi a eventi personali importanti, spesso traumatici, che non si spiegano con normale dimenticanza o con una condizione medica. Gli intervalli possono durare minuti, ore o giorni. A volte compare la fuga dissociativa, in cui la persona si allontana e può assumere nuove abitudini, con scarso ricordo del passato.
- Disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione: la persona sente il sé come “straniero” (depersonalizzazione) o percepisce l’ambiente come ovattato, distante, irreale (derealizzazione). Le funzioni cognitive restano integre, ma l’esperienza è inquietante.
- Disturbo dissociativo dell’identità (DID): caratterizzato dalla presenza di due o più stati dell’identità relativamente distinti con alterazioni nella memoria autobiografica e nella continuità del sé. Non si tratta di “personaggi inventati”, ma modi di funzionare nati per gestire traumi o stress. Possono emergere differenze in voce, postura, preferenze.
- Altri disturbi dissociativi specificati: quadri clinici significativi che non soddisfano pienamente i criteri dei precedenti, come episodi brevi e ripetuti di confusione identitaria o trance indotte da stress. Sono clinicamente rilevanti e meritano valutazione e cura.
- Dissociazione nel PTSD (sottotipo dissociativo): alcune persone con disturbo post-traumatico presentano depersonalizzazione o derealizzazione prominenti. Riconoscerlo guida gli interventi e il ritmo della terapia.
Da dove nasce la dissociazione? Quali cause e fattori di rischio contano davvero?
Perché alcune persone sviluppano un disturbo dissociativo mentre altre, pur vivendo esperienze difficili, no? Le risposte non sono semplici, ma la scienza ha individuato diversi fattori che, combinandosi, aumentano la vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi. Capire queste radici aiuta a riconoscere il disturbo e a superare pregiudizi ancora molto diffusi.
- Traumi evolutivi e stress prolungato: abusi, trascuratezza, violenza domestica o bullismoSebbene non esista una definizione di bullismo universalment... Leggi prolungato durante l’infanzia aumentano il rischio. Il cervello in sviluppo impara a “spacchettare” l’esperienza per ridurre il dolore.
- Eventi traumatici acuti: incidenti, aggressioni, catastrofi possono scatenare dissociazione per proteggere l’organismo dal sovraccarico. Subito dopo l’evento è frequente una “nebbia” percettiva che, se persiste, evolve in quadro clinico.
- AttaccamentoAttaccamento: il filo invisibile che connette le relazioni u... Leggi disorganizzato e rotture relazionali: quando la figura che dovrebbe consolare è anche fonte di pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi, la mente non ha una strategia coerente. Questo paradosso favorisce divisioni interne dell’esperienza e vulnerabilità dissociativa in adolescenzaPer adolescenza si intende il periodo di transizione dalla f... Leggi e in età adulta.
- Fattori neurobiologici: gli studi suggeriscono un’alterata integrazione tra reti cerebraliCome comunicano le reti cerebrali? Il cervello umano è comp... Leggi che regolano sé, memoria e salienza (es. default mode networkIl Default Mode Network (DMN) è una rete di regioni cerebra... Leggi, connettività ippocampo–amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi, modulazione dello stress). Non è “debolezza di carattere”: è neuropsicologia dell’adattamento sotto minaccia.
- Fattori culturali e contesto: alcune culture prevedono stati di trance rituale non patologici. Il confine con la clinica è dato da sofferenza, perdita di controllo e compromissione del funzionamento sociale o lavorativo.
- Sostanze e condizioni mediche: uso di sedativi, allucinogeni o crisiLa parola crisi evoca immagini di instabilità, difficoltà ... Leggi epilettiche del lobo temporale possono produrre esperienze simili. Per questo la valutazione deve considerare sempre cause organiche e iatrogeniche.
Come si manifesta nella vita quotidiana e quali sono le ricadute psicologiche e sociali?
La dissociazione ha un impatto concreto su scuola, lavoro, relazioni. Non è solo “sentirsi strani”. Una persona con amnesia dissociativa può scoprire email inviate senza ricordarle; qualcuno con derealizzazione fatica a seguire una riunione perché tutto appare lontano, come dietro un vetro; nel DID, la discontinuità del sé può generare cambi di comportamento che gli altri interpretano come incoerenza o “volubilità”. Le conseguenze psicologiche includono ansia anticipatoria (“e se succede di nuovo mentre guido?”), vergognaLa vergogna, un'emozione profondamente radicata nella percez... Leggi e isolamento. La vergogna contribuisce a mantenere il disturbo: temendo giudizi, molte persone nascondono i sintomi e ritardano la richiesta d’aiuto. Nella sfera sociale emergono incomprensioni: partner e colleghi interpretano i vuoti di memoria come scuse, i cambi di tono come manipolazione. Sul lavoro possono nascere errori, ritardi, conflitti; a scuola, cali di rendimento e assenze. Spesso coesistono cefalee, disturbi del sonnoCos'è il sonno e perché è importante? Il sonno è uno sta... Leggi, somatizzazioni. La comorbilità con depressione e PTSD aumenta il rischio di comportamenti autolesivi, specialmente nei momenti di “stordimento” dissociativo in cui la regolazione emotiva è fragile. Sul piano legale, la dissociazione può complicare testimonianze o ricordi di eventi critici, richiedendo competenze forensi specifiche.
Come si fa diagnosi? Quali strumenti usa il clinico e perché sono importanti?
- Colloquio clinico e anamnesi centrata sul trauma: il professionista esplora storia di vita, episodi di “perdita di tempo”, sensazioni di distaccoIn psicologia, il distacco indica la capacità — o la tend... Leggi, trigger specifici. Domande semplici ma operative (“Le capita di trovarsi in un luogo senza sapere come ci è arrivato?”) aiutano a far emergere fenomeni spesso taciuti per imbarazzoL’imbarazzo è un’emozione sociale che si manifesta in s... Leggi.
- Scale e interviste standardizzate: strumenti come la Dissociative Experiences Scale (DES) per lo screening, e interviste cliniche strutturate (ad esempio per i disturbi dissociativi) migliorano l’affidabilità diagnostica. Non sostituiscono il giudizio clinico, ma riducono bias e sottostima.
- Esame dello stato mentale e osservazione: il clinico valuta oscillazioni di voce, postura, cambi di consapevolezza, micro-amnesie durante il colloquio, fluttuazioni nella continuità del racconto. Annotare il contesto e i trigger (stimoli che riattivano ricordi, emozioni o reazione) permette di pianificare la stabilizzazione.
- Diagnosi differenziale e condizioni mediche: vanno escluse cause neurologiche (epilessia, encefalopatie), effetti di sostanze o farmaci, disturbi psicotici, demenze. In caso di sintomi atipici è utile il consulto con neurologia o medicina interna, e talvolta esami strumentali.
- Valutazione della comorbilità: ansia, depressione, PTSD, disturbi da uso di sostanze o tratti borderline influenzano il quadro e la prognosi. Riconoscerli guida priorità e ritmo della terapia, evitando interventi troppo rapidi sull’elaborazione del trauma.
- Coinvolgimento di familiari o figure di riferimento: con consenso dell’interessato, informazioni collaterali aiutano a mappare episodi di assenza, cambi di comportamento e strategie già efficaci. Fornire psicoeducazione alla rete riduce stigma e conflitti.
Si può guarire? Quali trattamenti funzionano e cosa aspettarsi nel percorso?
Il trattamento efficace segue di solito un modello a fasi. La prima fase è la stabilizzazione: si lavora sulla sicurezza, sul sonno, su routine prevedibili e su tecniche di grounding per riancorare l’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi al presente: si tratta di semplici strategie pratiche che aiutano a ridurre la sensazione di distacco e confusione tipica della dissociazione. Si introduce la psicoeducazione: capire che cos’è la dissociazione riduce paura e vergogna. La seconda fase, quando i sintomi sono più gestibili, include terapie focalizzate sul trauma, come l’EMDR o approcci cognitivi-comportamentali adattati alla dissociazione. L’obiettivo non è rivivere tutto, ma integrare in modo tollerabile memorie e significati. Nei casi in cui la persona percepisce parti diverse di sé come separate tra loro si lavora sull’integrazione funzionale: migliorare cooperazioneLa forza silenziosa che tiene insieme i gruppi umani La coop... Leggi interna, continuità della memoria, consenso sugli obiettivi quotidiani. I farmaci non curano la dissociazione in sé, ma possono alleviare sintomi collaterali (ansia, depressione, insonniaL'insonnia è un disturbo del sonno che si manifesta con la ... Leggi), facilitando il lavoro psicoterapeutico. Nella vita di tutti i giorni aiutano piani pratici: promemoria esterni, quaderni di bordo per gli episodi di “tempo perso”, accordi chiari con familiari e colleghi su come aiutare senza invadere. La prognosi è variabile ma incoraggiante quando si combinano terapia informata sul trauma, alleanza di cura stabile e contesto di supporto. Disinformazione e sensazionalismo online possono confondere: cercare professionisti formati e fonti affidabili è parte della cura.
- Bailey, T. D., & Brand, B. L. (2017). Traumatic dissociation: Theory, research, and treatment. Clinical Psychology: Science and Practice, 24(2), 170.
- Blihar, D., Delgado, E., Buryak, M., Gonzalez, M., & Waechter, R. (2020). A systematic review of the neuroanatomy of dissociative identity disorder. European Journal of Trauma & Dissociation, 4(3), 100148.
- Dorahy, M. J., Gold, S. N., & O’Neil, J. A. (Eds.). (2022). Dissociation and the dissociative disorders: Past, present, future. Taylor & Francis.
- Goldstein, M. R. (2025). Introduction to Dissociative Disorders: A Comprehensive Guide to Understanding, Treatment, Support, and Perspectives for Therapists and Families.
- Loewenstein, R. J., & Putnam, F. W. (2017). Dissociative disorders. Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry, 1, 1866-1952.
- Lynn, S. J., Berg, J. M., Lilienfeld, S. O., Merckelbach, H., Giesbrecht, T., Kloet, D. V. H. V. D., … & Polizzi, C. P. (2018). Dissociative disorders. Adult Psychopathology and Diagnosis, Eighth Edition, 451-496.
- Lyssenko, L., Schmahl, C., Bockhacker, L., Vonderlin, R., Bohus, M., & Kleindienst, N. (2018). Dissociation in psychiatric disorders: A meta-analysis of studies using the dissociative experiences scale. American Journal of Psychiatry, 175(1), 37-46.
- Modesti, M. N., Rapisarda, L., Capriotti, G., & Del Casale, A. (2022). Functional neuroimagingIl neuroimaging è una disciplina scientifica di grande rile... Leggi in dissociative disorders: a systematic review. Journal of personalized medicine, 12(9), 1405.
- Reinders, A. A., & Veltman, D. J. (2021). Dissociative identity disorder: out of the shadows at last? The British Journal of Psychiatry, 219(2), 413-414.
- Subramanyam, A. A., Somaiya, M., Shankar, S., Nasirabadi, M., Shah, H. R., Paul, I., & Ghildiyal, R. (2020). Psychological interventions for dissociative disorders. Indian journal of psychiatry, 62(Suppl 2), S280-S289.
- https://www.psicolinea.it/il-disturbo-dissociativo-dellidentita-did/ Consultato ad ottobre 2025
- https://www.stateofmind.it/disturbo-dissociativo/page/2/ Consultato ad ottobre 2025
- https://www.psychiatry.org/patients-families/dissociative-disorders/what-are-dissociative-disorders Consultato ad ottobre 2025
- https://www.nami.org/about-mental-illness/mental-health-conditions/dissociative-disorders/Consultato ad ottobre 2025
- Foto su Freepik

LEGGI APPASSIONATAMENTE
Il periodico semestrale sugli stili di vita e le risorse interioriCosa sono le risorse interiori e perché sono fondamentali? ... Leggi, le emozioni, le relazioni e le intelligenze, per una salute globale
"*" indica i campi obbligatori
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria
Parole chiave
- memoria
- identità
- emozioni
- confusione
- stress
- dolore
- ansia
- depressione
- stigma
- Amnesia
- vulnerabilità
- bullismo
- Attaccamento
- paura
- adolescenza
- reti cerebrali
- default mode network
- amigdala
- crisi
- vergogna
- sonno
- distacco
- imbarazzo
- attenzione
- cooperazione
- insonnia
- neuroimaging
- salute mentale
- risorse interiori
- intelligenza emotiva
- perdono