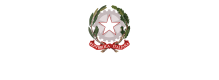Salute mentale
Ritiro sociale
INDICE
ToggleIl ritiro sociale: quando il silenzio diventa una forma di sopravvivenza
Negli ultimi decenni, il fenomeno del ritiro sociale ha attirato l’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi di psicologi, sociologi e neuroscienziati per la sua crescente diffusione, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Si tratta di una condizione in cui la persona si isola progressivamente dal mondo esterno, riducendo o interrompendo del tutto i contatti sociali, scolastici e lavorativi. Il ritiro non è semplicemente una “fase di chiusura” o timidezza accentuata, ma un processo complesso che può trasformarsi in un vero e proprio disturbo del comportamento sociale.
In Giappone, questo fenomeno è conosciuto come hikikomori — termine oggi utilizzato anche in Occidente per descrivere situazioni di isolamento volontario che possono durare mesi o anni. Dietro a questo silenzioIl silenzio, spesso trascurato nella frenesia della vita mod... Leggi non si nasconde solo la pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi del giudizio o l’ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi sociale, ma spesso una combinazione di fattori psicologici, familiari e culturali. Il ritiro può diventare una forma estrema di autodifesa, una risposta a un mondo percepito come troppo competitivo, imprevedibile o privo di senso. Comprendere il fenomeno significa esplorare i confini tra salute e disagio, libertà e prigionia, protezione e perdita di contatto con la realtà.
Perché alcune persone scelgono di ritirarsi dal mondo?
Le cause del ritiro sociale sono molteplici e intrecciate, rendendo difficile individuare un’unica spiegazione. Gli studi più recenti indicano che si tratta di un fenomeno multifattoriale, dove componenti psicologiche, familiari e sociali agiscono in modo combinato. Tra i principali fattori di rischio possiamo individuare:
- Disturbi d’ansia e dell’umore: molte persone che si ritirano sperimentano un’intensa ansia sociale o depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi. L’interazione con gli altri diventa fonte di stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi e il ritiro rappresenta un modo per ridurre l’angoscia legata al giudizio o al fallimento.
- Pressione scolastica o lavorativa: nei contesti competitivi, la paura di non essere all’altezza o di deludere le aspettative può spingere il soggetto a fuggire dalla scena sociale, rinunciando progressivamente a partecipare.
- Famiglie iperprotettive o disfunzionali: relazioni familiari ambivalenti, caratterizzate da controllo eccessivo o comunicazione fragile, possono indebolire la capacità di autonomia e la fiduciaLa fiducia, un'emozione cruciale nel tessuto delle relazioni... Leggi in sé.
- Influenza dei media digitali: internet e i videogiochi online offrono uno spazio sicuro dove rifugiarsi, ma spesso rinforzano l’isolamento, creando un circolo vizioso tra comfort virtuale e paura del mondo reale.
Come si manifesta il ritiro sociale nella vita quotidiana?
Il ritiro sociale non si presenta in modo uniforme, ma segue un’evoluzione graduale che può durare settimane, mesi o anni. Gli studiosi individuano diversi segnali e comportamenti caratteristici, che spesso vengono sottovalutati nei primi stadi. Questi comportamenti, se non riconosciuti in tempo, possono consolidarsi fino a rendere molto difficile la ripresa di una vita relazionale normale. Tra i più comuni troviamo:
- Riduzione progressiva delle attività esterne: inizialmente la persona evita solo alcune situazioni (scuola, eventi sociali, incontri di gruppo), fino ad arrivare a non uscire più di casa.
- Inversione del ritmo sonno-veglia: molte persone in ritiro vivono di notte e dormono di giorno, adattando i propri tempi a un mondo “parallelo” più silenzioso e prevedibile.
- Uso massiccio dei media digitali: il contatto con la realtà avviene quasi esclusivamente attraverso schermi, chat e giochi online, che diventano un modo per mantenere un minimo di interazione senza rischiare l’esposizione diretta.
- Calo dell’autostimaIl termine autostima indica, letteralmente, la valutazione d... Leggi e della cura di sé: con il tempo si riduce l’interesse per l’igiene personale, l’abbigliamento o l’alimentazioneLa vita non conosce pause: in ogni essere vivente le funzion... Leggi, segno di una perdita di motivazioneLa motivazione: un punto di vista scientifico La motivazione... Leggi e di progettualità.
- Difficoltà di comunicazione anche con i familiari: la chiusura può diventare totale, con il rifiuto di ogni forma di contatto verbale o fisico.
Quali sono le conseguenze psicologiche e sociali del ritiro?
Le conseguenze del ritiro sociale toccano profondamente la salute mentaleSecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute m... Leggi e il benessere globale della persona. Non si tratta solo di solitudineLa solitudine è un'emozione complessa caratterizzata da un ... Leggi, ma di un vero e proprio impoverimento dell’esperienza umana. Gli effetti più rilevanti includono:
- Depressione e perdita di senso: l’isolamento prolungato accentua i pensieri negativi e la sensazione di inutilità. Senza feedback sociali, la persona tende a costruire un’immagine di sé sempre più distorta.
- Compromissione delle capacità cognitive e relazionali: la mancanza di stimoli esterni riduce la flessibilità mentale, la memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi sociale e la capacità empatica, rendendo più difficile un eventuale reinserimento.
- Dipendenze comportamentali: l’uso eccessivo di internet o dei videogiochi può trasformarsi in una dipendenzaLa dipendenza psicologica è una condizione in cui una perso... Leggi che rafforza il ciclo di isolamento.
- Conflitti familiari e perdita del ruolo sociale: genitori e conviventi vivono spesso un forte senso di impotenza, e le tensioni domestiche aumentano, aggravando ulteriormente la chiusura.
- Rischio di esclusioneL’“Esclusione” non è soltanto un concetto sociale o p... Leggi economica: nel lungo periodo, il ritiro comporta la perdita di opportunità lavorative e formative, favorendo situazioni di marginalità.
La solitudine cronica non è solo un disagio psicologicoNel corso della vita, ognuno di noi attraversa fasi compless... Leggi: numerose ricerche mostrano come possa avere effetti fisici sul corpo, aumentando il rischio di infiammazioni, disturbi metabolici e indebolimento del sistema immunitario.
Come si può intervenire per favorire il ritorno alla vita sociale?
Il percorso di uscita dal ritiro sociale richiede tempo, delicatezza e un approccio integrato. Gli interventi più efficaci combinano supporto psicologico, accompagnamento educativo e collaborazione familiare. Ogni intervento deve essere personalizzato: il ritiro non è una “malattia” da curare, ma una condizione da comprendere, ascoltare e accompagnare con rispetto. Le strategie più utilizzate includono:
- Psicoterapia individuale: approcci come la terapia cognitivo-comportamentale o la terapia sistemico-relazionale aiutano a ricostruire l’autostima e a gestire l’ansia legata al contatto sociale.
- Interventi domiciliari o online: nei casi più gravi, l’incontro con l’operatore avviene a casa o in modalità digitale, per ridurre l’impatto dell’esposizione e favorire un graduale riavvicinamento.
- Coinvolgimento della famiglia: la famiglia è un attore chiave. Attraverso interventi educativi a supporto psicologico può imparare a sostenere il processo di riapertura senza pressioni o giudizi.
- Progetti di socializzazione graduale: laboratori, gruppi di interesse o attività artistiche consentono di riattivare la curiositàLa curiosità è un'emozione fondamentale che si manifesta c... Leggi e la motivazione, elementi fondamentali per riprendere fiducia nel mondo.
- Interventi scolastici e comunitari: prevenire è possibile attraverso programmi educativi che promuovono la gestione dell’ansia, il senso di appartenenza e la valorizzazione delle differenze.
Può il ritiro sociale diventare una risorsa per ripensare il nostro tempo?
Pur rappresentando una forma di sofferenza, il ritiro sociale ci pone di fronte a una domanda più ampia: quale spazio ha oggi l’intimità, il silenzio, la lentezza nella nostra società iperconnessa? In un mondo che esige prestazione continua e visibilità costante, il ritiro può essere letto anche come un segnale culturale, una protesta silenziosa contro l’eccesso di stimoli, di richieste e di confronto.
Alcuni studiosi suggeriscono che la crescita del fenomeno rifletta il bisogno, soprattutto tra i giovani, di riformulare il senso della relazione e dell’identitàIdentità: la trama invisibile che tiene insieme chi siamo L... Leggi in un contesto dove tutto sembra misurato in termini di successo e produttività. Tuttavia, perché questa pausa diventi davvero trasformativa e non autodistruttiva, è necessario che sia accompagnata da consapevolezza e supporto. Uscire dal ritiro non significa solo “tornare nel mondo”, ma imparare a costruire un rapporto più sano con sé stessi e con gli altri. In questa prospettiva, il fenomeno del ritiro ci obbliga a ripensare il concetto di benessere: non come mera integrazione sociale, ma come equilibrio dinamico tra interiorità e partecipazione, tra protezione e apertura alla vita.
Scarica l’edukit e inizia ad allenare la tua intelligenza emotiva
"*" indica i campi obbligatori
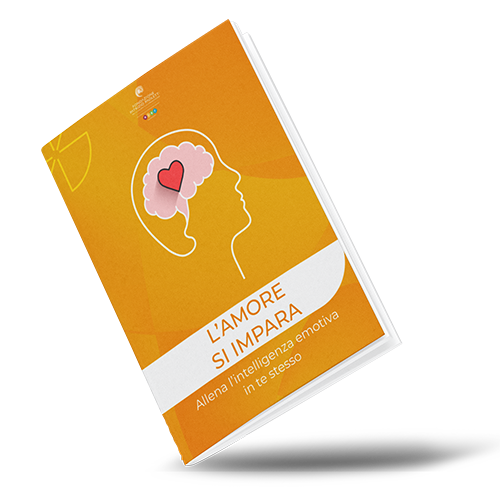
L'AMORE SI IMPARA
- Barzeva, S. A., Meeus, W. H., & Oldehinkel, A. J. (2019). Social withdrawal in adolescence and early adulthood: Measurement issues, normative development, and distinct trajectories. Journal of abnormal child psychology, 47(5), 865-879.
- Brandt, L., Liu, S., Heim, C., & Heinz, A. (2022). The effects of social isolationSocial isolation is a psychological and social phenomenon th... Leggi stress and discrimination on mental health. Translational psychiatry, 12(1), 398.
- Coplan, R. J., Bowker, J. C., & Nelson, L. J. (Eds.). (2021). The handbook of solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone. John Wiley & Sons.
- Da Re, L., & Perulli, L. (Eds.). (2025). Il ritiro sociale in adolescenzaPer adolescenza si intende il periodo di transizione dalla f... Leggi: Attualità e prospettive. FrancoAngeli.
- Gardiner, C., Geldenhuys, G., & Gott, M. (2018). Interventions to reduce social isolation and loneliness among older people: an integrative review. Health & social care in the community, 26(2), 147-157.
- Gazelle, H., Shafer Lundin, J. K., Lei, H., Cao, H., & Litchfield, M. (2024). Child and adolescent social withdrawal predict adult psychosocial adjustment: A meta-analysis. Frontiers in Developmental Psychology, 2, 1408166.
- Lancini, M. (2020). Il ritiro sociale negli adolescenti: la solitudine di una generazione iperconnessa. Raffaello Cortina Editore.
- National Academies of Sciences, Medicine, Division of Behavioral, Medicine Division, Board on Behavioral, Sensory Sciences, … & Loneliness in Older Adults. (2020). Social isolation and loneliness in older adults: Opportunities for the health care system. National Academies Press.
- Rubin, K. H., & Chronis‐Tuscano, A. (2021). Perspectives on social withdrawal in childhood: Past, present, and prospects. Child Development Perspectives, 15(3), 160-167.
- Xiong, Y., Hong, H., Liu, C., & Zhang, Y. Q. (2023). Social isolation and the brain: effects and mechanisms. Molecular psychiatry, 28(1), 191-201.
- https://centrostudi.gruppoabele.org/?page_id=17153 Consultato a ottobre 2025
- https://www.tuopsicologo.it/2024/09/26/psicologia-del-ritiro-sociale-in-adulti-e-adolescenti/ Consultato a ottobre 2025
- https://www.verywellmind.com/what-causes-social-withdrawal-7095469 Consultato a ottobre 2025
- https://www.justonenorfolk.nhs.uk/emotional-health/children-young-peoples-emotional-health/social-withdrawal/ Consultato a ottobre 2025
- https://nurselinecs.co.uk/blog/social-withdrawal-and-its-early-warning-signs/ Consultato a ottobre 2025
- Foto su Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria