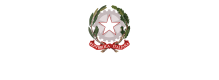Salute mentale
Disturbo antisociale di personalità
INDICE
ToggleDisturbo antisociale di personalità: quando il rispetto delle regole viene meno
Il disturbo antisociale di personalità (DAP) rappresenta una delle condizioni psicologiche più controverse e difficili da affrontare, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista sociale. Chi ne è affettoChe cos'è l'affetto secondo la scienza? L'affetto rappresen... Leggi manifesta un disprezzo persistente per i diritti altrui, le norme condivise e le regole del vivere civile. Non si tratta solo di una questione di comportamento scorretto o ribellione giovanile: il DAP è una diagnosi clinica complessa, inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), che comporta profonde implicazioni a livello emotivo, relazionale e legale. Il disturbo compare di solito già in età adolescenziale, attraverso forme precoci di condotta deviata, e si consolida nella prima età adulta. Spesso viene confuso con il comportamento criminale in generale, ma non tutti i criminali soffrono di DAP, né tutte le persone con DAP commettono reati gravi.
Quali sono le caratteristiche principali del disturbo antisociale di personalità?
Il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da un insieme coerente di comportamenti e atteggiamenti che si manifestano fin dalla prima adolescenzaPer adolescenza si intende il periodo di transizione dalla f... Leggi e persistono nell’età adulta. La diagnosi, secondo il DSM-5, richiede che siano presenti almeno tre dei seguenti criteri:
- DisprezzoIl disprezzo è un'emozione complessa che si manifesta quand... Leggi per le norme sociali e legali: la persona infrange regolarmente le leggi, può essere coinvolta in attività criminali o violente, tende a considerare le regole come ostacoli da aggirare piuttosto che come limiti da rispettare.
- Inganno e manipolazione: mentire, usare pseudonimi o truffare gli altri per profitto o piacereIl piacere è un'esperienza soggettiva che descrive una sens... Leggi personale è un comportamento ricorrente. Il soggetto può apparire affascinante e persuasivo, ma utilizza queste doti per manipolare.
- Impulsività e incapacità di pianificare: chi soffre di DAP agisce senza riflettere sulle conseguenze, passando da un’attività all’altra senza continuità o senso di responsabilità.
- Irritabilità e aggressività: frequenti litigi, aggressioni fisiche o verbali e un basso livello di tolleranza alla frustrazioneLa frustrazione, dal punto di vista neuroscientifico e psico... Leggi sono tratti distintivi.
- Disregolazione affettiva e assenza di rimorsoIl rimorso è un'emozione articolata e dolorosa che emerge q... Leggi: la persona mostra indifferenzaL'indifferenza è un'emozione o stato affettivo caratterizza... Leggi verso i sentimenti altrui, non prova senso di colpaIl senso di colpa è un'emozione che si manifesta quando una... Leggi dopo aver fatto del male e spesso razionalizza le proprie azioni.
Questi comportamenti, se persistenti e pervasivi, non sono soltanto indice di difficoltà relazionali ma configurano una vera e propria alterazione del funzionamento psichico che ostacola la costruzione di legami stabili e l’integrazione sociale.
Come si sviluppa questo disturbo e quali sono le sue cause?
Il disturbo antisociale di personalità ha origini multifattoriali, che combinano elementi genetici, neurobiologici, ambientali ed esperienziali. La ricerca scientifica ha evidenziato come la sua comparsa sia spesso il risultato di un’interazione complessa tra vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi innate e fattori di rischio esterni. Tra le principali cause e condizioni di sviluppo troviamo:
- Ereditarietà e predisposizione genetica: studi condotti su gemelli e famiglie indicano una componente ereditaria importante. Se uno dei genitori ha un disturbo della personalità o un comportamento antisociale, il rischio per i figli aumenta.
- Alterazioni neurobiologiche: risonanze magnetiche e altri esami hanno mostrato anomalie funzionali nella corteccia prefrontaleLa corteccia prefrontale svolge un ruolo fondamentale in num... Leggi (responsabile del controllo degli impulsi) e nell’amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi (coinvolta nella regolazione delle emozioniCosa significa regolare le emozioni? La regolazione delle em... Leggi). Tali anomalie compromettono la capacità di empatiaL'empatia è un'abilità fondamentale che ci consente di ent... Leggi, pianificazione e giudizio morale.
- Esperienze traumatiche infantili: abuso fisico, trascuratezza emotiva, esposizione a violenza domestica o ambienti disfunzionali sono fortemente correlati allo sviluppo di comportamenti antisociali.
- Disturbo della condotta in età evolutiva: molti adulti con DAP hanno avuto diagnosi di disturbo della condotta da bambini, caratterizzato da atti vandalici, crudeltà verso animali, menzogne e violazioni gravi delle regole.
Queste componenti non agiscono isolatamente: è proprio la loro interazione a determinare il rischio di sviluppare un disturbo antisociale strutturato, specialmente in assenza di interventi precoci o supporti educativi adeguati.
In che modo il disturbo antisociale influisce sulla vita sociale e relazionale?
Le ripercussioni del disturbo antisociale di personalità si manifestano in tutti i contesti relazionali della persona: famiglia, lavoro, amicizie, convivenze. L’impossibilità di costruire rapporti basati sulla fiduciaLa fiducia, un'emozione cruciale nel tessuto delle relazioni... Leggi reciproca, sull’empatia e sulla responsabilità rende spesso instabili e conflittuali i legami con gli altri.
- Relazioni affettive problematiche. Chi ha un disturbo antisociale tende a instaurare relazioni superficiali, dominate da controllo, manipolazione o violenza. L’incapacità di riconoscere e rispettare i sentimenti altrui mina la possibilità di costruire legami duraturi e sani.
- Ambiente lavorativo instabile. Impulsività, disonestà o mancanza di rispetto per le gerarchie compromettono la permanenza in contesti professionali strutturati. La persona può cambiare spesso lavoro o trovarsi coinvolta in episodi di mobbing o conflitto.
- Conflitti con la legge. L’aspetto più visibile del DAP è spesso la recidività in comportamenti criminali: truffe, furti, violenze, violazione della libertà vigilata. Tuttavia, non tutti i soggetti antisociali agiscono in modo plateale: alcuni mantengono una facciata di normalità e agiscono in modo subdolo, come nel caso di truffatori o manipolatori seriali.
La difficoltà nel costruire una rete sociale stabile contribuisce all’isolamento e alla cronicizzazione del disturbo, accentuando la sfiducia verso l’esterno e rafforzando un senso distorto di superiorità o disprezzo verso gli altri.
Come viene diagnosticato e trattato il disturbo antisociale di personalità?
La diagnosi del DAP non è semplice e richiede una valutazione clinica approfondita, spesso condotta da psichiatri o psicologi esperti in disturbi di personalità. La difficoltà maggiore risiede nella scarsa consapevolezza che il soggetto ha del proprio disturbo e nella sua tendenza a mentire o manipolare anche in ambito terapeutico.
- Criteri diagnostici strutturati: la diagnosi si basa sul DSM-5, che richiede che i tratti antisociali siano stabili, pervasivi e presenti almeno dall’età di 15 anni. È necessario escludere condizioni come la schizofreniaLa schizofrenia è una delle patologie psichiatriche più co... Leggi o il disturbo bipolareIl disturbo bipolare è un disturbo psichiatrico complesso c... Leggi che possono causare comportamenti simili.
- Valutazione psicologica e comportamentale: interviste strutturate, test di personalità e osservazione clinica sono strumenti fondamentali per rilevare i tratti distintivi del disturbo.
- Terapia cognitivo-comportamentale (CBT): anche se i risultati sono spesso limitati, può aiutare a ridurre la frequenza dei comportamenti disfunzionali, migliorare il controllo degli impulsi e aumentare la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.
- Farmacoterapia: non esistono farmaci specifici per il DAP, ma in alcuni casi si utilizzano stabilizzatori dell’umore, antipsicotici o antidepressivi per trattare sintomi associati come aggressività, ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi o depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi.
Il successo del trattamento dipende dalla motivazioneLa motivazione: un punto di vista scientifico La motivazione... Leggi del paziente, dalla stabilità dell’ambiente in cui vive e dalla presenza di una rete di supporto. Nei contesti penitenziari o giudiziari, l’aderenza ai programmi terapeutici può essere obbligata, ma questo non garantisce un vero cambiamento.
Quali sono le conseguenze sociali e culturali di questo disturbo?
I comportamenti antisociali generano un alto costo sociale in termini di sicurezza pubblica, giustizia, sanità e perdita di produttività. Le implicazioni culturali e mediatiche del DAP sono oggetto di crescente attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi.
- Stigmatizzazione e spettacolarizzazione: la figura del “sociopatico” o “psicopatico” è spesso rappresentata nei media in modo sensazionalistico, creando confusioneLa confusione è un'emozione caratterizzata da incertezza, d... Leggi tra disturbo antisociale e criminalità estrema. Questo alimenta stereotipi e ostacola una comprensione scientifica del fenomeno.
- Costi economici e sanitari: il disturbo antisociale di personalità è particolarmente diffuso tra coloro che entrano in contatto con il sistema giudiziario e carcerario. Il trattamento, la sorveglianza e le ricadute di azioni illegali rappresentano un peso considerevole per le istituzioni.
- Problemi di prevenzione e inclusioneL'inclusione non è solo una parola chiave dei nostri tempi,... Leggi: l’identificazione precoce del disturbo e l’attivazione di interventi nei contesti educativi e familiari sono cruciali, ma spesso trascurati. La mancanza di strumenti e risorse adeguate rende difficile agire prima che i comportamenti antisociali si consolidino.
- Impatto relazionale ed emotivo su vittime e familiari: le persone che entrano in relazione con un individuo affetto da DAP spesso riportano traumi psicologici duraturi, dipendenzaLa dipendenza psicologica è una condizione in cui una perso... Leggi emotiva o difficoltà nel liberarsi da relazioni tossiche.
Comprendere il disturbo antisociale di personalità in tutta la sua complessità significa andare oltre le etichette, promuovendo consapevolezza, prevenzione e strategie di intervento che tutelino sia il singolo sia la società nel suo insieme.
Scarica l’edukit e inizia ad allenare la tua intelligenza emotiva
"*" indica i campi obbligatori
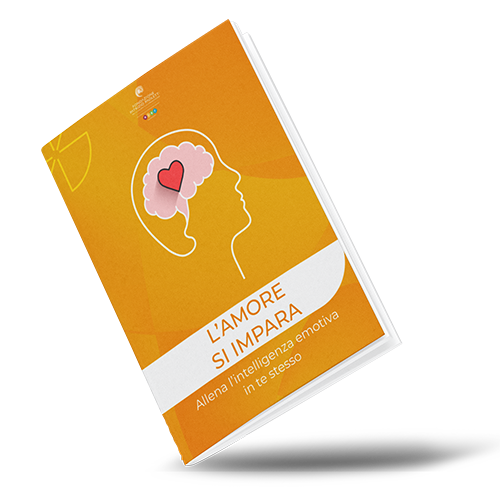
L'AMORE SI IMPARA
- Anderson, J. L., & Kelley, S. E. (2022). Antisocial personality disorder and psychopathy: The AMPD in review. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 13(4), 397.
- Black, D. W. (2015). The natural history of antisocial personality disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, 60(7), 309-314.
- Black, D. W. (2017). The treatment of antisocial personality disorder. Current Treatment Options in Psychiatry, 4(4), 295-302.
- Espiridion, E. D., & Kerbel, S. A. (2020). A systematic literature review of the association between somatic symptom disorder and antisocial personality disorder. Cureus, 12(7).
- Glenn, A. L., Johnson, A. K., & Raine, A. (2013). Antisocial personality disorder: a current review. Current psychiatry reports, 15(12), 427.
- Mulay, A. L., & Cain, N. M. (2020). Antisocial personality disorder. In Encyclopedia of personality and individual differences (pp. 206-215). Springer, Cham.
- Raine, A. (2018). Antisocial personality as a neurodevelopmental disorder. Annual review of clinical psychology, 14(1), 259-289.
- Storebø, O. J., & Simonsen, E. (2016). The association between ADHDL'ADHD, acronimo di Attention Deficit Hyperactivity Disorder... Leggi and antisocial personality disorder (ASPD) a review. Journal of attention disorders, 20(10), 815-824.
- Tapasi, G. A., & Nurcahyo, R. W. (2024). Antisocial Personality Disorder (ASPD). Literature Review Practices in Psychology: Contemplative Papers from 2023 Undergraduate Students, 59.
- https://www.intherapy.it/disturbo/antisociale-personalita-disturbo Consultato a luglio 2025
- https://www.stateofmind.it/disturbo-antisociale-di-personalita/ Consultato a luglio 2025
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20353928 Consultato a luglio 2025
- https://www.healthdirect.gov.au/antisocial-personality-disorder Consultato a luglio 2025
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria
Parole chiave
- affetto
- adolescenza
- Disprezzo
- piacere
- frustrazione
- rimorso
- indifferenza
- senso di colpa
- vulnerabilità
- corteccia prefrontale
- amigdala
- regolazione delle emozioni
- empatia
- fiducia
- schizofrenia
- disturbo bipolare
- ansia
- depressione
- motivazione
- attenzione
- confusione
- inclusione
- dipendenza
- salute mentale
- ADHD
- intelligenza emotiva
- salute globale
- silenzio