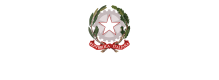Salute mentale
Psicosi
INDICE
ToggleQuando la mente perde contatto con la realtà
Il termine psicosi indica una condizione mentale grave in cui una persona perde il contatto con la realtà, sperimentando alterazioni profonde della percezione, del pensiero e del comportamento. A differenza di disturbi d’ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi o dell’umore, dove il soggetto mantiene un senso critico sulla propria condizione, nella psicosi questo senso di realtà si altera o svanisce del tutto. Le persone che vivono uno stato psicotico possono avere allucinazioni (percezioni sensoriali senza uno stimolo esterno) o deliri (credenze false e rigide non condivise dalla cultura di riferimento). Si tratta di un insieme eterogeneo di sintomi che possono manifestarsi in modo acuto o graduale e che influenzano profondamente la capacità della persona di comprendere e interpretare il mondo circostante.
Le psicosi non costituiscono una diagnosi unica, ma un insieme di sindromi che comprendono, tra le altre, la schizofreniaLa schizofrenia è una delle patologie psichiatriche più co... Leggi, il disturbo schizoaffettivo, il disturbo deliranteIl disturbo delirante è una condizione psicopatologica comp... Leggi e la psicosi breve reattiva. Possono anche manifestarsi in modo transitorio in condizioni di forte stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi, uso di sostanze psicoattive o in corso di patologie neurologiche. La psicosi, dunque, non è una malattia “in sé”, ma un’esperienza mentale complessa e multifattoriale, la cui comprensione richiede una prospettiva integrata: biologica, psicologica e sociale. L’intervento precoce è essenziale: il tempo che passa senza cure durante un episodio psicotico influisce molto su come evolverà la malattia.
Come si riconoscono i sintomi della psicosi? Da cosa ha origine questa frattura con la realtà? E che impatto ha sul vissuto personale e sulla società?
Quali sono i principali sintomi della psicosi?
I sintomi psicotici si dividono solitamente in positivi, negativi e cognitivi, a seconda delle funzioni mentali coinvolte e del modo in cui si esprimono. Ecco una panoramica dettagliata dei principali segni clinici della psicosi:
- Allucinazioni: percezioni sensoriali che avvengono senza stimoli reali. Le più frequenti sono uditive (voci che commentano, accusano o dialogano tra loro), ma possono anche essere visive, olfattive o tattili. Queste esperienze sono vissute come reali dal soggetto e ciò può generare grande angoscia o comportamenti disorganizzati.
- Deliri: convinzioni false e incrollabili, spesso di tipo persecutorio (“qualcuno mi sta spiando”), di grandezza (“sono stato scelto per salvare il mondo”) o di riferimento (“i notiziari parlano di me”). I deliri influenzano il modo in cui la persona interpreta la realtà e le relazioni con gli altri.
- Disorganizzazione del pensiero e del linguaggio: difficoltà a seguire un filo logico nel ragionamento o nel discorso. La persona può passare da un argomento all’altro senza connessioni chiare, rendendo difficile la comprensione da parte dell’interlocutore.
- Sintomi negativi: riduzione delle emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi espresse, apatia, ritiro socialeNegli ultimi decenni, il fenomeno del ritiro sociale ha atti... Leggi, difficoltà a iniziare o portare a termine attività quotidiane. Questi sintomi possono essere meno eclatanti dei deliri o delle allucinazioni, ma compromettono fortemente la qualità della vita.
- Compromissioni cognitive: difficoltà di attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi, memoriaLa memoria è una funzione cognitiva fondamentale che consis... Leggi, pianificazione e flessibilità mentale. Queste alterazioni rendono più difficile il funzionamento quotidiano e la partecipazione sociale e lavorativa.
La combinazione e l’intensità dei sintomi variano da persona a persona, rendendo ogni esperienza psicotica unica. Tuttavia, un riconoscimento tempestivo può fare la differenza nel prevenire l’aggravarsi della condizione.
Da dove nasce la psicosi? Quali sono le cause conosciute?
Le origini della psicosi sono complesse e multifattoriali, risultato dell’interazione tra predisposizione biologica e fattori ambientali. Capire le cause della psicosi è essenziale per sviluppare strategie preventive efficaci, personalizzare i trattamenti e ridurre lo stigmaLo stigma verso la salute mentale è definibile come il preg... Leggi che spesso circonda questa condizione. La ricerca scientifica ha individuato numerose componenti che contribuiscono allo sviluppo di una condizione psicotica:
- Fattori genetici: avere un parente di primo grado affettoChe cos'è l'affetto secondo la scienza? L'affetto rappresen... Leggi da un disturbo psicotico aumenta il rischio individuale. Tuttavia, la genetica da sola non basta: molti soggetti geneticamente predisposti non svilupperanno mai la malattia.
- Alterazioni neurochimiche: uno squilibrio nei sistemi di neurotrasmettitori, in particolare della dopaminaUn neurotrasmettitore che si trova nel cervello e nel sistem... Leggi, è associato alla comparsa di sintomi psicotici. L’ipotesi dopaminergica è una delle più studiate, ma anche glutammato e serotoninaLa serotonina, nota anche come 5-idrossitriptamina (5-HT), ... Leggi sono implicati.
- Eventi stressanti o traumatici: esperienze traumatiche precoci (come abusi, trascuratezza o perdita di un genitore) possono aumentare la vulnerabilitàLa vulnerabilità è uno stato emotivo che si verifica quand... Leggi psicotica. Lo stress acuto può essere un fattore scatenante in soggetti predisposti.
- Uso di sostanze: cannabis ad alta concentrazioneChe cos’è davvero la concentrazione e perché oggi è cos... di THC (tetraidrocannabinolo), LSD, cocaina e anfetamine sono state associate a episodi psicotici, soprattutto in soggetti giovani o vulnerabili. In alcuni casi, l’uso cronico può favorire l’esordio di una psicosi persistente.
- Condizioni mediche e neurologiche: infezioni, tumori cerebrali, epilessia, malattie autoimmuni o squilibri metabolici possono causare sintomi psicotici. In questi casi si parla di psicosi secondarie.
- Fattori culturali e sociali: l’isolamento, la discriminazioneNel tessuto sociale contemporaneo, il tema della discriminaz... Leggi o l’essere migrante possono rappresentare fattori di rischio aggiuntivi. Il contesto sociale, infatti, può modulare il modo in cui si esprimono o vengono interpretati i sintomi.
Come si diagnostica una psicosi e quali strumenti vengono utilizzati?
La diagnosi di psicosi è clinica, cioè basata sull’osservazione dei comportamenti, sul colloquio con il paziente e sull’anamnesi. Non esistono esami di laboratorio o test strumentali che da soli siano in grado di “diagnosticare” una psicosi, ma diversi strumenti sono impiegati per comprendere meglio il quadro clinico.
I professionisti della salute mentaleSecondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute m... Leggi, come psichiatri e psicologi, si avvalgono di criteri diagnostici standardizzati (DSM-5 o ICD-11) per identificare la presenza e la tipologia dei sintomi. Vengono valutati aspetti come la durata dei sintomi, la loro gravità, il grado di compromissione del funzionamento quotidiano e l’eventuale presenza di cause organiche o tossiche. Spesso si utilizzano anche scale psicometriche (es. PANSS, BPRS) per monitorare l’andamento del disturbo nel tempo o l’efficacia dei trattamenti. In presenza di sospetti di psicosi secondarie, si ricorre a esami ematochimici, risonanza magneticaLa risonanza magnetica (RM) è una tecnica non invasiva di i... Leggi cerebrale o elettroencefalogramma per escludere altre patologie.
Importante è anche il coinvolgimento della famiglia e del contesto sociale nella fase valutativa: le informazioni fornite dai caregiver possono essere determinanti per identificare segnali precoci o cambiamenti significativi nel comportamento. La diagnosi precoce, seguita da un trattamento adeguato, rappresenta il fattore più importante per migliorare la prognosi e ridurre il rischio di ricadute.
In che modo si cura la psicosi? Quali sono gli approcci più efficaci?
Il trattamento della psicosi prevede un intervento multidisciplinare e integrato, che tenga conto sia dei sintomi acuti che dei bisogni a lungo termine della persona. Le principali strategie terapeutiche includono:
- Farmacoterapia antipsicotica: i farmaci antipsicotici (neurolettici) sono il pilastro del trattamento. Agiscono modulando i neurotrasmettitori, in particolare la dopamina. Ne esistono di prima e seconda generazione, con profili di efficacia e tollerabilità diversi. Sebbene non “curino” la psicosi, aiutano a ridurre i sintomi e prevenire le ricadute.
- Psicoterapia cognitivo-comportamentale (CBT): supporta il paziente nel riconoscere i pensieri disfunzionali, ridurre l’impatto dei deliri e gestire le allucinazioni. È efficace soprattutto in fase post-acuta e nei casi in cui permane una parziale consapevolezza critica.
- Interventi psicosociali: comprendono programmi di riabilitazione cognitiva, training sulle abilità socialiIl cuore relazionale della competenza emotiva Quando si parl... Leggi, supporto all’inserimento lavorativo e abitativo. Il loro obiettivo è migliorare il funzionamento globale e l’autonomia del paziente.
- Supporto familiare e psicoeducazione: coinvolgere la famiglia nel percorso terapeutico è fondamentale. La psicoeducazione aiuta a comprendere la natura della malattia, a riconoscere i segnali di ricaduta e a migliorare la comunicazione all’interno del nucleo familiare.
- Interventi precoci (Early Intervention Services): rivolti ai giovani con esordio psicotico, riducono significativamente le ospedalizzazioni e migliorano l’aderenza al trattamento. Includono monitoraggio clinico, supporto psicologico e accompagnamento sociale.
La cura della psicosi è un processo a lungo termine. È essenziale evitare l’interruzione precoce delle cure e promuovere una presa in carico continua, centrata sulla persona e sulla qualità della sua vita.
Quali sono le implicazioni psicologiche e sociali della psicosi?
La psicosi non è solo una condizione medica, ma un’esperienza esistenziale che può avere profonde conseguenze sul vissuto personale e sulla vita sociale. Chi vive una psicosi spesso affronta un senso di perdita: della propria identità, delle relazioni, delle prospettive di vita. Le fasi acute possono essere traumatiche, sia per il soggetto che per chi gli sta vicino, lasciando un senso di frattura con la propria biografia. A ciò si aggiungono lo stigma e la discriminazione, che restano tra gli ostacoli principali alla piena partecipazione sociale. La pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi, l’ignoranza e i pregiudizi diffusi possono spingere le persone con psicosi verso l’isolamento, rendendo più difficile la ripresa. Non è raro che si inneschino circoli viziosi di esclusioneL’“Esclusione” non è soltanto un concetto sociale o p... Leggi sociale, povertà, emarginazioneL’emarginazione è un fenomeno trasversale che attraversa ... Leggi e presenza di altri disturbi psichici o dipendenze.
Sul piano relazionale, la psicosi può generare fratture profonde: amicizie e legami familiari spesso si incrinano, mentre le possibilità di costruire una carriera lavorativa o un progetto di vita autonomo si riducono. Tuttavia, esistono anche storie di recupero, in cui la persona, grazie a un supporto adeguato e a un contesto accogliente, riesce a reintegrarsi nella società. Promuovere una cultura della salute mentale, contrastare lo stigma e potenziare i servizi territoriali sono azioni fondamentali per rendere la psicosi una condizione affrontabile e non una condanna alla marginalità. Come società, la sfida non è solo clinica, ma anche etica e culturale.
Che cosa è per te la salute?
Insieme per
una salute globale
- Amsalem, D., Valeri, L., Jankowski, S. E., Yang, L. H., Bello, I., Nossel, I., … & Dixon, L. B. (2022). Reducing public stigma toward individuals with psychosis across race and gender: a randomized controlled trial of young adults. Schizophrenia Research, 243, 195-202.
- Calabrese, J., & Al Khalili, Y. (2023). Psychosis. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.
- Colizzi, M., Ruggeri, M., & Lasalvia, A. (2020). Should we be concerned about stigma and discrimination in people at risk for psychosis? A systematic review. Psychological medicine, 50(5), 705-726.
- Devoe, D. J., Braun, A., Seredynski, T., & Addington, J. (2020). Negative symptoms and functioning in youth at risk of psychosis: a systematic review and meta-analysis. Harvard review of psychiatry, 28(6), 341-355.
- Fusar-Poli, P., De Pablo, G. S., Correll, C. U., Meyer-Lindenberg, A., Millan, M. J., Borgwardt, S., … & Arango, C. (2020). Prevention of psychosis: advances in detection, prognosis, and intervention. JAMA psychiatry, 77(7), 755-765.
- Fusar-Poli, P., De Pablo, G. S., Rajkumar, R. P., López-Díaz, Á., Malhotra, S., Heckers, S., … & Pillmann, F. (2022). Diagnosis, prognosis, and treatment of brief psychotic episodes: a review and research agenda. The Lancet Psychiatry, 9(1), 72-83.
- Julayanont, P., & Suryadevara, U. (2021). Psychosis. CONTINUUM: Lifelong LearningIl termine "Lifelong Learning", o apprendimento permanente, ... Leggi in Neurology, 27(6), 1682-1711.
- Smith, C. M., Komisar, J. R., Mourad, A., & Kincaid, B. R. (2020). COVID-19-associated brief psychotic disorder. BMJ Case Reports CP, 13(8), e236940.
- Stahl, S. M. (2018). Beyond the dopamine hypothesis of schizophrenia to three neural networks of psychosis: dopamine, serotonin, and glutamate. CNS spectrums, 23(3), 187-191.
- Sterzer, P., Adams, R. A., Fletcher, P., Frith, C., Lawrie, S. M., Muckli, L., … & Corlett, P. R. (2018). The predictive coding account of psychosis. Biological psychiatry, 84(9), 634-643.
- https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/psicosi Consultato ad agosto 2025
- https://ipsico.it/sintomi-cura/psicosi-disturbo-psicotico/ Consultato ad agosto 2025
- https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/23012-psychosis Consultato ad agosto 2025
- https://medicine.yale.edu/psychiatry/step/psychosis/ Consultato ad agosto 2025
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria