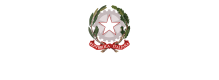Intelligenza emotiva
Pregiudizio
INDICE
ToggleCos’è un pregiudizio e perché è tanto difficile da riconoscere?
Il pregiudizio è un giudizio anticipato e generalizzato su persone, gruppi sociali o situazioni, formulato senza un’effettiva conoscenza dei fatti. Nasce spesso da stereotipi, cioè credenze semplificate e rigide che attribuiamo a un’intera categoria (etnica, culturale, di genere, ecc.). A differenza dell’opinione consapevole, il pregiudizio si fonda su convinzioni radicate, emotivamente cariche e resistenti al cambiamento, anche di fronte a prove contrarie. È insidioso perché può presentarsi in modo implicito, ovvero automatico e non intenzionale: ad esempio, possiamo sorridere meno a una persona solo perché riteniamo inconsciamente che non appartenga al “nostro” gruppo.
Un aspetto affascinante è che i pregiudizi non riguardano solo gli altri: esistono anche pregiudizi intra-gruppo (cioè rivolti verso persone del proprio stesso gruppo) e auto-pregiudizi (forme interiorizzate di discriminazioneNel tessuto sociale contemporaneo, il tema della discriminaz... Leggi). Per esempio, una donna potrebbe credere inconsciamente che le donne siano meno adatte alla leadership. Questo rende il tema ancora più complesso e urgente da comprendere, soprattutto in una società che si propone come equa e inclusiva. Il pregiudizio, dunque, non è un semplice errore di valutazione: è una lente distorta che condiziona la percezione, il comportamento e le relazioni sociali.
Da dove nascono i pregiudizi? Quali sono le loro radici psicologiche e sociali?
I pregiudizi hanno radici profonde e stratificate. Sono il prodotto di un intreccio tra processi cognitivi, influenze culturali, dinamiche sociali e fattori evolutivi. Questi elementi agiscono spesso sotto la soglia della consapevolezza, rendendo difficile distinguere tra ciò che pensiamo autonomamente e ciò che abbiamo assorbito passivamente. Ecco alcune delle principali fonti da cui si originano i pregiudizi:
- Categorizzazione automatica. Il nostro cervello tende a semplificare la realtà suddividendo persone e situazioni in categorie. Questa funzione, utile per orientarsi nel mondo complesso, può però portare a sovra-generalizzazioni e stereotipi, facilitando il sorgere di pregiudizi.
- Bisogno di appartenenza. Gli esseri umani sviluppano un forte senso di identità sociale. Questo porta a preferire chi è simile a noi e a diffidare di chi è diverso, anche senza motivo concreto. Tale meccanismo rinforza i confini sociali e alimenta la discriminazione.
- Esperienze precoci e modelli educativi. I pregiudizi si apprendono anche attraverso la famiglia, i media e l’istruzione. Frasi come “tutti i rom sono ladri” o “le donne sono più emotive degli uomini” trasmettono modelli mentali che si radicano fin dall’infanzia.
- Influenza dei media. Film, notizie e social network possono rafforzare immagini distorte, esagerando o selezionando solo alcuni aspetti di una realtà complessa. Questo fenomeno, chiamato framing, può alimentare paure ingiustificate e ostilità verso determinati gruppi.
In quali forme si manifesta il pregiudizio nella vita quotidiana?
Il pregiudizio assume molteplici forme, alcune evidenti, altre più sottili ma non meno dannose. Identificarle è il primo passo per contrastarle in modo efficace. Ecco alcune delle principali modalità con cui si esprime:
- Pregiudizio esplicito. È quello più visibile e dichiarato. Comprende insulti, atti discriminatori, commenti offensivi e negazione di diritti. È ancora diffuso, anche se meno accettato socialmente.
- Pregiudizio implicito. Agisce in modo inconscio. Può manifestarsi in decisioni lavorative (preferire candidati di un certo sesso o etnia), nel linguaggio non verbale (mancanza di contatto visivo) o nell’atteggiamento (sospetto immotivato verso certe persone).
- Discriminazione sistemica. Il pregiudizio si incarna anche in norme, istituzioni e politiche che penalizzano interi gruppi. Esempi includono la scarsa rappresentanza femminile nei ruoli di potere o le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione e alla sanità.
- Micro-pregiudizi. Si tratta di piccole azioni o commenti apparentemente innocui, ma che colpiscono ripetutamente le persone di un certo gruppo. Frasi come “Parli italiano molto bene!” dette a un cittadino straniero nato in Italia, possono avere un impatto negativo cumulativo.
- Auto-pregiudizio. Alcune persone interiorizzano gli stereotipi che la società ha su di loro. Questo può portare a bassa autostimaIl termine autostima indica, letteralmente, la valutazione d... Leggi, senso di inadeguatezza o autoesclusione da opportunità importanti.
Che conseguenze ha il pregiudizio su individui e società?
I pregiudizi non sono solo un problema etico: hanno conseguenze misurabili sulla salute globaleNel vasto e sfaccettato panorama della salute globale, la de... Leggi, sul benessere e sul funzionamento delle società. Questi effetti rendono urgente un’azione consapevole, non solo individuale ma anche collettiva, per smantellare le basi culturali e istituzionali del pregiudizio. Ecco i principali effetti documentati:
- Danni psicologici e fisici. Chi subisce pregiudizi può sperimentare ansiaL'ansia è una risposta emotiva caratterizzata da sentimenti... Leggi, depressioneLa depressione è un disturbo caratterizzato da una tristezz... Leggi, disturbi psicosomatici e calo dell’autoefficaciaDi fronte alle sfide quotidiane che dobbiamo affrontare, ogn... Leggi. La discriminazione cronica è considerata un fattore di rischio per molte malattie, comprese quelle cardiovascolari.
- Effetto Pigmalione negativo. Le aspettative distorte influenzano la performance. Se un insegnante ritiene che gli alunni stranieri siano meno capaci, tenderà (inconsciamente) a dedicare loro meno attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi, confermando le sue stesse convinzioni.
- Mancanza di coesione sociale. Le società fortemente pregiudizievoli sono meno solidali, più conflittuali e meno capaci di integrare la diversità come risorsa. Questo genera tensioni, polarizzazioni e sfiducia generalizzata.
- Perdita di talentoNell'antica Grecia, il talento era una misura di peso utiliz... Leggi e opportunità. I pregiudizi limitano l’accesso a risorse, formazione e occupazione, escludendo interi segmenti della popolazione. Le aziende e le comunità che discriminano rinunciano a competenze e idee preziose.
- Effetto boomerang. I gruppi dominanti che perpetuano il pregiudizio possono essere anch’essi danneggiati, ad esempio alimentando la pauraLa paura è un’emozione primaria che si attiva in risposta... Leggi del diverso o irrigidendo le norme sociali. In un mondo globalizzato, questo riduce la capacità di adattamento e innovazione.
È possibile superare i pregiudizi? Con quali strategie efficaci?
Superare i pregiudizi non è semplice, ma è possibile, soprattutto se si agisce su più livelli: individuale, educativo, relazionale e sociale. Ecco alcune strategie efficaci supportate dalla ricerca scientifica:
- Educazione critica e interculturale. Promuovere una cultura del pensiero critico e dell’empatia sin dalla scuola aiuta a riconoscere e decostruire gli stereotipi. I programmi educativi basati sul dialogoDialogo: quando le parole diventano relazione Il dialogo è ... Leggi tra culture favoriscono l’apertura mentale.
- Contatto inter-gruppi positivo. Interagire con persone appartenenti a gruppi diversi riduce la paura e favorisce la comprensione. Il contatto deve però essere significativo, paritario e supportato da obiettivi comuni (es. progetti di lavoro collaborativi).
- Consapevolezza dei bias impliciti. Strumenti come l’Implicit Association Test (IAT) permettono di rilevare i propri pregiudizi automatici. Essere consapevoli dei propri bias è il primo passo per ridurne l’impatto nelle decisioni quotidiane.
- Modelli positivi e testimonianze. L’esposizione a figure pubbliche che contrastano gli stereotipi (es. scienziate donne, imprenditori rom, atleti con disabilità) amplia l’immaginario collettivo e riduce la rigidità delle categorie sociali.
- Interventi istituzionali e normativi. Politiche di inclusioneL'inclusione non è solo una parola chiave dei nostri tempi,... Leggi, quote di rappresentanza, formazione obbligatoria sulla diversità nei luoghi di lavoro sono strumenti efficaci per agire su larga scala e modificare i comportamenti.
Queste azioni richiedono continuità e convinzione, ma possono produrre cambiamenti profondi nella mentalità e nei rapporti sociali.
Perché il pregiudizio riguarda tutti noi, anche se pensiamo di esserne immuni?
È facile pensare che i pregiudizi siano un problema “degli altri”, magari dei meno istruiti o dei più intolleranti. In realtà, il pregiudizio è una componente universale del funzionamento umano. Tutti, nessuno escluso, ne siamo portatori in forma più o meno consapevole. Questo perché il cervello è programmato per economizzare energia e prendere decisioni rapide: categorizzare è una scorciatoia mentale inevitabile. La vera differenza sta nel riconoscerlo e lavorare per ridurne l’influenza. Il pregiudizio non è una “colpa” individuale, ma diventa una responsabilità collettiva quando condiziona le scelte educative, lavorative o politiche. Anche i contesti apparentemente più progressisti – come università, ONG, redazioni giornalistiche – possono veicolare stereotipi nascosti, se non si attiva un’autentica riflessione critica.
In definitiva, affrontare il tema del pregiudizio non significa puntare il dito, ma assumere uno sguardo più consapevole e aperto. Significa chiederci ogni giorno: sto davvero ascoltando l’altro per quello che è, o per quello che penso che sia? Solo ponendoci queste domande possiamo contribuire a costruire una società più giusta, inclusiva e intelligente.
Una video-lezione sulla neuro-plasticità per capire come allenare la mente a trasformarsi, apprendere e crescere a ogni età.
"*" indica i campi obbligatori

IL CERVELLO CHE CAMBIA
- Agustin, M., Djoehaeni, H., & Gustiana, A. D. (2021, March). Stereotypes and prejudices in young children. In 5th International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020) (pp. 302-305). Atlantis Press.
- Amodio, D. M., & Cikara, M. (2021). The social neuroscience of prejudice. Annual review of psychology, 72(1), 439-469.
- Cowan, P., & Maitles, H. (2023). Does addressing prejudice and discrimination through Holocaust education produce better citizens? In Mapping the Field (pp. 147-162). Routledge.
- Esses, V. M. (2021). Prejudice and discrimination toward immigrants. Annual review of psychology, 72(1), 503-531.
- Hudson, S. K. T. J., Myer, A., & Berney, E. C. (2024). Stereotyping, prejudice, and discrimination at the intersection of race and gender: An intersectional theory primer. Social and Personality Psychology Compass, 18(2), e12939.
- Kite, M. E., Whitley Jr, B. E., & Wagner, L. S. (2022). Psychology of prejudice and discrimination. Routledge.
- Payne, B. K., & Hannay, J. W. (2021). Implicit bias reflects systemic racism. Trends in cognitive sciences, 25(11), 927-936.
- Paluck, E. L., Porat, R., Clark, C. S., & Green, D. P. (2021). Prejudice reduction: Progress and challenges. Annual review of psychology, 72(1), 533-560.
- https://openstax.org/books/introduction-sociology-3e/pages/11-3-prejudice-discrimination-and-racism Consultato ad aprile 2025
- https://www.simplypsychology.org/prejudice.html Consultato ad aprile 2025
- https://www.unife.it/letterefilosofia/filo.edu/insegnamenti/psicologia_sociale/materiale-didattico/a-a-2017-2018/Cap.4%20psico%20sociale.pdf Consultato ad aprile 2025
- https://www.studocu.com/it/document/universita-cattolica-del-sacro-cuore/psicologia-sociale/il-pregiudizio/8479100 Consultato ad aprile 2025
- Foto su Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria