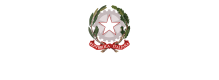Salute mentale
Estraniamento
INDICE
ToggleEstraniamento: quando la realtà diventa distante
Ci sono momenti in cui il mondo sembra perdere consistenza: i suoni si ovattano, le persone diventano figure distanti e anche noi stessi sembriamo osservatori di una vita che non ci appartiene del tutto. È in questo spazio sospeso che nasce l’estraniamento, una condizione in cui la connessioneConnessione: il bisogno umano che precede ogni tecnologia La... Leggi abituale con la realtà si indebolisce. Non si tratta di semplice distrazione o stanchezzaLa stanchezza è un'esperienza comune che può manifestarsi ... Leggi, ma di una vera e propria alterazione percettiva e affettiva che può coinvolgere corpo, mente e relazioni. Le neuroscienzeIl cervello umano è una delle strutture più complesse e af... Leggi lo descrivono come un disallineamento tra le reti cerebraliCome comunicano le reti cerebrali? Il cervello umano è comp... Leggi della coscienzaLa coscienza è uno dei temi più misteriosi e affascinanti ... Leggi e della percezione, mentre la psicologiaLa psicologia è la scienza che esplora la mente, le emozion... Leggi lo interpreta come un meccanismo di difesa contro un eccesso di stimoli o di doloreIl dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva complessa, ... Leggi. Ma l’estraniamento è anche un tema profondamente culturale: la sensazione di vivere “fuori dal mondo” attraversa la letteratura, l’arte e la società contemporanea, segnalando la fragilità del nostro legame con ciò che ci circonda. Comprenderlo significa esplorare non solo una condizione psicologica, ma uno dei modi in cui la mente umana reagisce alla complessità dell’esistenza.
Che cosa accade nel cervello quando ci si sente estraniati?
Dal punto di vista neuroscientifico, l’estraniamento è il risultato di una disconnessione temporanea tra aree cerebrali che regolano la percezione di sé e la consapevolezza del corpo. Diversi studi hanno individuato le basi neurobiologiche di questa condizione:
- IperattivitàL’iperattività è una condizione caratterizzata da un liv... Leggi dell’amigdalaL'amigdala è una formazione di sostanza grigia che prende i... Leggi: l’amigdala, centro della risposta emotiva, può entrare in stato di iperallerta, amplificando la percezione di minaccia. Questo induce il cervello a “staccare” parzialmente dalla realtà per proteggersi, generando una sensazione di distaccoIn psicologia, il distacco indica la capacità — o la tend... Leggi o irrealtà.
- Ridotta integrazione nella corteccia prefrontaleLa corteccia prefrontale svolge un ruolo fondamentale in num... Leggi: la zona prefrontale, deputata al controllo cognitivo e all’autoconsapevolezzaIl termine autoconsapevolezza (a volte utilizzato come sinon... Leggi, mostra una minore attività nei momenti di estraniamento. Ciò spiega perché chi lo sperimenta si senta “fuori da sé”, incapace di riconoscere emozioniLe emozioni sono risposte psicofisiologiche complesse che ci... Leggi o decisioni come proprie.
- Alterazioni del sistema vestibolare e somatosensoriale: il cervello integra in modo anomalo le informazioni sensoriali, provocando una sensazione di corpo “leggero” o “irreale”. È lo stesso meccanismo che può comparire nei disturbi di depersonalizzazione.
- Coinvolgimento dell’asse dello stressDal punto di vista clinico, lo stress è una reazione fisiol... Leggi (HPA): l’eccessiva produzione di cortisoloLe ghiandole surrenali, piccole ghiandole piramidali sopra i... Leggi durante periodi di tensione cronica riduce la capacità del cervello di elaborare correttamente gli stimoli emotivi, favorendo il distacco come meccanismo difensivo.
Questi processi mostrano che l’estraniamento non è solo una sensazione soggettiva, ma una vera e propria risposta neurofisiologica a situazioni di sovraccarico o trauma.
In quali forme psicologiche si manifesta l’estraniamento?
Dal punto di vista clinico, l’estraniamento può presentarsi in varie forme, alcune transitorie e altre più strutturate. Tra le principali:
- Depersonalizzazione: la persona si percepisce come spettatrice di sé stessa, come se osservasse le proprie azioni dall’esterno. È frequente in contesti di forte stress o panico.
- Derealizzazione: il mondo circostante appare strano, artificiale, privo di vita. Gli oggetti sembrano distanti o modificati nella forma e nel colore, come in un sogno.
- AlienazioneL’alienazione è un concetto centrale in psicologia e psic... Leggi sociale: si tratta di un distacco progressivo dalle relazioni umane, spesso legato a disagio esistenziale, isolamento sociale o eccessivo uso di tecnologie.
- Estraniamento emotivo: la persona conserva le facoltà cognitive ma perde la capacità di provare emozioni, un sintomo ricorrente nei disturbi depressivi o post-traumatici.
- Estraniamento artistico o intellettuale: in alcuni casi, l’estraniamento è ricercato come modalità di riflessione critica o di creazione estetica, come avviene nell‘effetto di estraniamento’ teorizzato da Bertolt Brecht.
L’estraniamento, dunque, non è un fenomeno unico, ma un insieme di esperienze che oscillano tra il disagio psicologicoNel corso della vita, ognuno di noi attraversa fasi compless... Leggi e la presa di distanza consapevole dalla realtà.
Perché la società contemporanea favorisce l’estraniamento?
Le condizioni sociali e tecnologiche odierne contribuiscono in modo significativo a far emergere o amplificare il senso di estraniamento. Alcuni fattori determinanti sono:
- Digitalizzazione delle relazioni: l’interazione mediata da schermi riduce la qualità del contatto umano e può generare una percezione di distanza affettiva. Si comunica di più, ma si sente di meno.
- Sovraccarico informativo: l’eccesso di stimoli cognitivi e notizie, spesso contraddittorie, spinge il cervello a disattivare i meccanismi di coinvolgimento emotivo come forma di difesa.
- Lavoro alienante e precarietà: la perdita di senso nel lavoro, unita all’instabilità economica, produce una frattura tra individuo e identitàIdentità: la trama invisibile che tiene insieme chi siamo L... Leggi professionale.
- Cultura dell’immagine e dell’apparenza: la pressione a costruire un sé “performante” sui social media genera una distanza crescente tra ciò che si mostra e ciò che si è.
- Disconnessione ecologica: l’allontanamento dalla natura e dai ritmi biologici naturali alimenta un senso di spaesamentoDefinizione neuroscientifica e psicologica Lo spaesamento è... Leggi e perdita di radici.
Tutti questi elementi convergono nel creare una condizione collettiva di estraneità, in cui il soggetto vive in perenne oscillazione tra iperconnessione e isolamento.
Quali strategie aiutano a riconnettersi con sé stessi e con il mondo?
Contrastare l’estraniamento richiede un lavoro di riconnessione graduale, che coinvolge mente, corpo e relazioni. Le strategie più efficaci includono:
- Pratiche di grounding: tecniche come la respirazione consapevole o il contatto con oggetti fisici servono a riportare l’attenzioneL'attenzione è un processo cognitivo complesso e multidimen... Leggi al corpo e al momento presente.
- Psicoterapia cognitivo-comportamentale o integrata: aiuta a riconoscere i pensieri di distacco e a ristrutturarli, ricostruendo un senso di continuità del sé.
- Attività corporee e creative: movimento, arte e musica favoriscono la riattivazione delle emozioni e la percezione unitaria del corpo.
- Connessione sociale autentica: relazioni basate sull’ascoltoAscoltare: un’abilità antica per un mondo complesso L’a... Leggi reciproco e sulla presenza fisica rappresentano un antidoto naturale all’estraniamento digitale.
- Immersione nella natura: il contatto diretto con ambienti naturali ripristina un senso di appartenenza e calmaLa calma è uno stato emotivo di tranquillità e pace. Da un... Leggi neurofisiologica, riducendo i livelli di cortisolo.
Queste pratiche, se mantenute con costanza, aiutano a reintegrare le dimensioni frammentate dell’esperienza, restituendo coerenza al vissuto personale.
Che cosa ci insegna l’estraniamento sulla condizione umana?
L’estraniamento, sebbene doloroso, è anche una lente rivelatrice. Mostra quanto la percezione di sé e del mondo sia fragile, costruita su un equilibrio dinamico tra presenza e distanza. Quando ci si sente improvvisamente distanti dalla realtà, si incrina l’illusione di una continuità stabile e affiora la natura instabile della coscienza. Filosofi come Heidegger e Sartre hanno interpretato questa esperienza come tratto costitutivo dell’esistenza: l’uomo, “gettato nel mondo”, vive un senso intermittente di estraneità, oscillando tra appartenenza e smarrimento. La scienza contemporanea, tuttavia, offre un’altra chiave di lettura. L’estraniamento può essere un meccanismo di difesa utile, una sospensione temporanea che consente alla mente di riorganizzare l’esperienza dopo un trauma o un sovraccarico emotivo. Non è solo perdita di contatto, ma anche un modo per ristabilire equilibrio e continuità interiore. La mente, in questo senso, non fugge dalla realtà: prende distanza per potersi riavvicinare con maggiore stabilità. In questa ambivalenza risiede il significato più profondo del fenomeno. L’essere umano, pur sentendosi talvolta distante dal mondo, tende sempre a ricercare un senso di appartenenza: agli altri, ai luoghi, al proprio corpo. L’estraniamento, allora, diventa il riflesso della tensione più intima della nostra specie — quella tra il bisogno di proteggersi e il desiderio di sentirsi pienamente vivi. Comprenderlo significa accettare che l’identità umana è un movimento continuo tra immersione e distanza, tra perdita e ritorno al mondo.
Portiamo la meditazioneEsistono tanti modi per definire la meditazione, ma forse il... Leggi nelle scuole italiane
- Burkitt, I. (2019). Alienation and emotion: social relations and estrangement in contemporary capitalism. Emotions and Society, 1(1), 51-66.
- Gatus, A., Jamieson, G., & Stevenson, B. (2022). Past and future explanations for depersonalization and derealization disorder: a role for predictive coding. Frontiers in human neuroscience, 16, 744487.
- Khan, M. A. (2021). Alienation and self-alienation. Journal of Development and Social Sciences, 2(3), 491-499.
- Michal, M. (2022). Depersonalization/derealization disorder. In Dissociation and the Dissociative Disorders (pp. 380-391). Routledge.
- Murphy, R. J. (2023). Depersonalization/derealization disorder and neural correlates of trauma-related pathology: A critical review. Innovations in clinical neuroscience, 20(1-3), 53.
- Seemann, A. (2023). Loneliness, psychological models, and self-estrangement. Topoi, 42(5), 1133-1142.
- Sierk, A., Daniels, J. K., Manthey, A., Kok, J. G., Leemans, A., Gaebler, M., … & Walter, H. (2018). White matter network alterations in patients with depersonalization/derealization disorder. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 43(5), 347-357.
- Tanaka, S. (2018). What is it like to be disconnected from the body? A phenomenological account of disembodiment in depersonalization/derealization disorder. Journal of Consciousness Studies, 25(5-6), 239-262.
- Yang, J., Millman, L. M., David, A. S., & Hunter, E. C. (2023). The prevalence of depersonalization-derealization disorder: a systematic review. Journal of Trauma & Dissociation, 24(1), 8-41.
- Wang, S., Zheng, S., Zhang, F. X., Ma, R., Feng, S., Song, M., … & Jia, H. (2024). The treatment of depersonalization-derealization disorder: A systematic review. Journal of Trauma & Dissociation, 25(1), 6-29.
- Wilkhoo, H. S., Islam, A. W., Reji, F., Sanghvi, L., Potdar, R., & Solanki, S. (2024). Depersonalization-derealization disorder: etiological mechanism, diagnosis and management. Discoveries, 12(2), e190.
- https://ipsico.it/news/depersonalizzazione-derealizzazione-sintomi-dissociativi/ Consultato a ottobre 2025
- https://psicoterapiascientifica.it/depersonalizzazione-derealizzazione/ Consultato a ottobre 2025
- https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9791-depersonalization-derealization-disorder Consultato a ottobre 2025
- https://www.psychologytoday.com/us/conditions/depersonalizationderealization-disorder Consultato a ottobre 2025
- Foto su Freepik
Sii parte del cambiamento. Condividere responsabilmente contenuti è un gesto che significa sostenibilità
Alleniamo l'intelligenza emotivaLa prima definizione di Intelligenza Emotiva in quanto tale ... Leggi: che emozione ti suscita questo articolo?
Potrebbe interessarti
Cerca per categoria